 | 3 Settembre 2009 |
DOSSIER: La Comunità di Sant'Egidio, storia collettiva di un'amicizia |
|
|
Nata a Roma negli anni della contestazione, la Comunità di Sant’Egidio ha saputo conservare la "voglia di ideali" di quel periodo di rinnovamento ecclesiale, senza perdere il radicamento nella Parola di Dio e il senso di appartenenza alla comunità cattolica. Dall’impegno accanto ai poveri a quello per la riconciliazione e il dialogo interreligioso, gli ex liceali di Trastevere hanno giocato la loro fede sulle frontiere della storia con ottimismo e creatività.
Forse è difficile trovare un’altra messa dove ogni tanto si incrociano due o tre ex presidenti della Repubblica. Seduti tra i banchi, insieme a un’assemblea composita, dove tra turisti, gente comune, stranieri, anziani, disabili, non è raro intravedere gente dello spettacolo e politici, uomini di cultura e della Curia romana, cardinali e vescovi. È un pezzo di mondo, una rappresentanza articolata del popolo di Dio che in questa basilica nel cuore di Trastevere, a Roma, si sente a casa. Una liturgia curata, omelie concise e pensate, e la sensazione di partecipare a un frammento di vita di una comunità che a messa si ritrova per fare sintesi di una storia più grande. Santa Maria in Trastevere è una parrocchia come le altre, dove trovi gli scout e i gruppi del Vangelo, ma è anche il "quartier generale" di Sant’Egidio.
 «Sant’Egidio esiste come fatto comunitario», dice il fondatore, lo storico Andrea Riccardi, nell’intervista che chiude questo dossier. Storia collettiva di un gruppo di liceali, dunque, più che "invenzione" di un unico capo carismatico. Non è un caso se gli studenti di ieri, smessa la borsa di tolfa e i loden, oggi sono responsabili dei principali settori della vita della Comunità, che conta circa 50 mila aderenti, in 73 Paesi nei cinque continenti, e mantiene un cuore italiano. Un’appartenenza che, come si racconta nelle pagine che seguono, non è part-time ma globale, e in qualche modo coinvolge scelte lavorative e familiari. «Sant’Egidio esiste come fatto comunitario», dice il fondatore, lo storico Andrea Riccardi, nell’intervista che chiude questo dossier. Storia collettiva di un gruppo di liceali, dunque, più che "invenzione" di un unico capo carismatico. Non è un caso se gli studenti di ieri, smessa la borsa di tolfa e i loden, oggi sono responsabili dei principali settori della vita della Comunità, che conta circa 50 mila aderenti, in 73 Paesi nei cinque continenti, e mantiene un cuore italiano. Un’appartenenza che, come si racconta nelle pagine che seguono, non è part-time ma globale, e in qualche modo coinvolge scelte lavorative e familiari.
La Comunità di Sant’Egidio è la prima realtà che Jesus incontra nel viaggio che parte tra le aggregazioni ecclesiali nate nel post-Concilio. Andare alla scoperta delle "opere" e dei "testimoni" per dire della vita, è la chiave di lettura che abbiamo scelto. Con i contributi di alcuni membri della Comunità raccontiamo le radici storiche e i progetti che negli anni hanno cambiato il volto di Sant’Egidio. Spesso si tratta di decisioni nate da un incontro, di "mandati" affidati da quei poveri che all’inizio sono stati la motivazione originale dei progetti e «negli anni hanno continuato a esserlo», dicono in Comunità, pur cambiando il contesto geografico e quello umano.
Da Roma all’Asia, dall’Africa all’America latina, Sant’Egidio ha moltiplicato le comunità nelle periferie urbane e sociali del mondo. Ma ha anche sollevato uno sguardo su un orizzonte più ampio, coniugando la vicinanza ai poveri con una diplomazia dal basso, che ha portato frutti di pace in diversi contesti di guerra, e con un impegno "politico" che ha significato interventi nei campi più diversi, dalla campagna per l’abolizione della pena di morte al progetto Dream per l’assistenza ai malati di Aids in Africa; dalle battaglie per leggi più rispettose dei diritti di immigrati e rifugiati alle proposte di politiche inclusive per il popolo rom; dai progetti per l’iscrizione all’anagrafe dei bambini invisibili alle campagne mediatiche contro una cultura della paura in nome di una falsa sicurezza.
Fortemente amata e sostenuta da Giovanni Paolo II, quella che i giornalisti chiamano «l’Onu di Trastevere» ha inoltre abbracciato "lo spirito di Assisi", sulla scia dell’incontro interreligioso del 1986 voluto da papa Wojtyla, facendosi promotrice ogni anno di una manifestazione che riunisce nella preghiera e nella riflessione i leader religiosi di tutto il mondo (quest’anno dal 6 all’8 settembre a Cracovia).
Oggi Sant’Egidio è una delle realtà più conosciute, più significative e anche – a suo modo – "potenti" tra quelle nate nel post-Concilio, ascoltate e interpellate dalle Chiese e dai governi. L’attenzione, però, è fare "centro" sempre sull’essenziale. Lo racconta bene Marco Impagliazzo, il presidente della Comunità, quando parla del crocifisso di legno antico, rimasto senza braccia, custodito nella sede di Trastevere: «Lo chiamiamo il Cristo dell’impotenza. La sfida è cercare di essere quelle braccia, cambiare il mondo con mezzi deboli, non con il potere».
di Vittoria Prisciandaro
Dal ’68 al mondo restando fedeli ai poveri
Nata nel tempo della contestazione studentesca, la Comunità di Trastevere è uscita arricchita dalle turbolenze politico-ecclesiali di quegli anni. Il suo segreto? Ce lo spiega lo storico Agostino Giovagnoli, che ha seguito da vicino questa vicenda originale.
«Le eruzioni che scuotono la nostra moderna società sono anche un’insurrezione inconscia contro la totale pianificazione della nostra esistenza», da cui deriva un’«impotenza dell’individuo, come forse mai prima d’ora c’era stata». Così osservava Joseph Ratzinger riferendosi al 1968, quando sui muri della Sorbona o di altre università europee gli studenti scrivevano: «Siate realisti, chiedete l’impossibile». Nel sottofondo della contestazione, c’era anche il presentimento della rivoluzione consumista, della società post-moderna e della «dittatura del relativismo» che, nei quarant’anni successivi, avrebbero cambiato radicalmente le nostre esistenze, modellandole spesso pesantemente. Si percepiva allora l’inizio di un’inedita dilatazione della soggettività individuale che, negli anni Settanta e Ottanta, sarebbe diventata esperienza diffusa e, persino, banale. La sensazione di diventare il «sovrano di sé stesso» spiega l’euforia di quegli anni segnati «da un senso di liberazione» che tuttavia preludeva all’inizio di una fase di «insicurezza identitaria», perché la «disgregazione delle comunità» avrebbe introdotto un’«incertezza radicale sulla continuità e la consistenza di sé» (Kaufmann). A suo modo il ’68 cercò di anticipare tutto questo, dando uno sbocco collettivo alle energie individuali liberate dalla dilatazione della soggettività. Michel de Certeau, un raffinato storico gesuita, cercò allora di spiegarsi quella esperienza scrivendo: «Dentro di noi, qualcosa ha cominciato a muoversi. Voci mai sentite ci hanno trasformato... Diventano nostre senza essere più il rumore soffocato delle nostre solitudini... Si è presa la parola come nel 1789 si è presa la Bastiglia... Una folla è diventata poetica. Ci si è messi finalmente a discutere di cose essenziali, di società, di felicità, di arte e di politica». Fu un tentativo, forse impossibile, di collegare alla grande tradizione umanistica europea i tempi nuovi della post-modernità e le terre incognite del consumismo. Nata nel 1968, la Comunità di Sant’Egidio è soprattutto figlia del Vaticano II e del suo spirito. Ma la primavera conciliare – che ha chiuso felicemente molte questioni aperte tra Chiesa e modernità, come, tra gli altri, i rapporti tra fede e razionalità, autorità e libertà, Chiesa cattolica e Stato liberal-democratico – si è dovuta misurare molto presto con le sfide e i problemi di un’epoca profondamente diversa. Anche la Comunità di Sant’Egidio si è trovata, fin dall’inizio, coinvolta in questioni come quelle poste dalla disgregazione dei rapporti sociali tradizionali: il suo cammino è iniziato con un confronto tra un gruppo di giovani sul problema della solitudine, che non era solo angoscia adolescenziale ma anche segno dei tempi. Sulla scia del Vaticano II, la comunità ha cercato nella tradizione della Chiesa nova et vetera, trovando anzitutto nella liturgia una risposta antica ma sempre attuale alla tensione tra esplosione della soggettività individuale e bisogno dell’altro, tra un "io" sempre più esigente e un "noi" sempre più imprevedibile. Nella preghiera, comunitaria e personale, incentrata sull’ascolto della Parola di Dio – cuore della proposta conciliare – essa ha trovato il suo fondamentale ubi consistam. È stata una scoperta legata anche a un intenso contatto iniziale con la tradizione benedettina, mentre nella figura di san Francesco la comunità ha trovato l’esempio di un’esperienza radicalmente evangelica e interamente laica, perché giocata non dentro la protezione di muri o di regole monastiche ma nelle dinamiche del cambiamento storico; dall’incontro con figure come padre Pedro Arrupe, Preposito generale della Compagnia di Gesù, ha ricavato la lezione dell’evangelizzazione in contesti culturali diversi e molteplici; dall’amicizia con il grande teologo Yves Congar ha tratto l’insegnamento di una profonda fedeltà alla Chiesa e di una larghezza di respiro storico. La Comunità, insomma, ha potuto attingere a tanti diversi frutti del grande rinnovamento conciliare. Del clima della fine degli anni Sessanta Sant’Egidio ha condiviso le letture a tutto campo, ma se ne è distinta per l’ancoraggio, fermo, nella lettura biblica e nel rifiuto dell’ideologia come madre onnicomprensiva. Il radicamento evangelico ha costituito un antidoto e una presa di distanza radicale, personale, spirituale, da ogni forma di violenza, che avrebbe progressivamente imbarbarito la ricerca e la "poesia" del ’68, fino al neo-totalitarismo dei «processi proletari», del pensiero unico, delle aggressioni armate, della lotta contro lo Stato. E in un confronto con i testi e il vocabolario che ha dato vita nei decenni successivi anche a un’intera classe dirigente di giornalisti, intellettuali, partendo dal filone marxista-leninista del post ’68, colpisce la prosa a-ideologica, il ridotto "gergo interno" della Comunità di Sant’Egidio anche ai suoi inizi, l’insistenza per un’adesione che non può che essere sempre rinnovata ogni giorno e fondata sul "volentieri" e non su un inquadramento organizzato. È una peculiarità, a suo modo, anche rispetto a consolidate esperienze ecclesiali cresciute nel pre-Concilio, con cui nel tempo Sant’Egidio ha stabilito rapporti fraterni e ha lavorato a un vero e proprio movimento di amicizia tra movimenti e aggregazioni ecclesiali, pur rappresentando un’evoluzione peculiare e diversa dal tradizionale associazionismo cattolico. Rispetto al dibattito degli anni Cinquanta, fino agli anni Settanta, centrato spesso sul confronto filosofico tra marxismo e cristianesimo, e sulla "teologia fondamentale", Sant’Egidio nasce "post", e più radicata nella storia della Chiesa, nel recupero della grande diversità esistente al suo interno, nella liberazione e nel rinnovamento di energie nella storia, naturalmente laico nel suo approccio, e naturalmente radicato all’interno della grande tradizione cristiana. Orto-prassi in aggiunta all’ortodossia. Di qui una capacità insolita di dialogo con il "mondo moderno" e con l’intellettualità "laica", una capacità di coinvolgimento oltre gli schemi abituali.
 Dopo il 1968, molte cose sono cambiate. Negli anni Settanta, la voce anticonformista di Pier Paolo Pasolini cominciò a denunciare l’omologazione antropologica provocata dal consumismo, incitando il Papa a prendere la guida dell’opposizione contro i consumi e la televisione. La Chiesa, invece, non ha scomunicato né gli uni né l’altra. Qualcuno si è scandalizzato, altri hanno approfittato di questa "mancata" condanna ma, contrariamente ai timori dei primi e alle speranze dei secondi, gli sviluppi successivi hanno mostrato che il consumismo non ha creato un totale "vuoto etico": condannarlo in toto sarebbe stato perciò sbagliato, oltre che inutile. Invece del "vuoto etico" si è prodotta, piuttosto, una grande "frammentazione etica", attraverso la moltiplicazione dei valori e dei fini cui ispirare scelte e comportamenti (dall’uguaglianza alla diversità, dall’ecologia alla pace, dalla tolleranza alla solidarietà, dall’autonomia individuale alla coesione sociale...). Sul piano morale, si è chiesto all’individuo di non uniformare più le sue scelte a principi e regole prefissati, ma di scegliere o, persino, di "produrre" egli stesso i valori e le norme cui ispirarsi (Taylor). In questo modo, l’indubbio ampliamento delle possibilità è stato spesso vanificato dalla difficoltà di individuare motivi esistenzialmente e storicamente validi cui riferire singole decisioni e scelte di vita. Così, pur intravedendo miraggi di onnipotenza, l’individuo finisce spesso per fare esperienze di impotenza, con una fuga dalle responsabilità non molto diversa dalla fuga dalla libertà descritta a suo tempo da Erich Fromm. Ma non è un destino obbligato. La Comunità di Sant’Egidio è diventata famosa nel mondo per l’impegno di pace, ma i risultati ottenuti da quella che è stata chiamata «l’Onu di Trastevere» sono il frutto di un’azione semplice svolta da gente comune. Se in passato erano le grandi Potenze a decidere la guerra e la pace – ha ricordato più volte Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità – oggi anche l’individuo comune può fare qualcosa di rilevante per la pace o per la guerra. Nella sua semplicità, tale affermazione implica che ognuno può contribuire a cambiare il mondo e che il mondo può diventare completamente diverso da come è attualmente. Ma occorre trovare la strada. Nelle situazioni complesse e ambivalenti, come quella in cui viviamo, più importante di un giudizio sicuro su uomini, idee, avvenimenti, è infatti non smarrire l’orientamento. Dopo il 1968, molte cose sono cambiate. Negli anni Settanta, la voce anticonformista di Pier Paolo Pasolini cominciò a denunciare l’omologazione antropologica provocata dal consumismo, incitando il Papa a prendere la guida dell’opposizione contro i consumi e la televisione. La Chiesa, invece, non ha scomunicato né gli uni né l’altra. Qualcuno si è scandalizzato, altri hanno approfittato di questa "mancata" condanna ma, contrariamente ai timori dei primi e alle speranze dei secondi, gli sviluppi successivi hanno mostrato che il consumismo non ha creato un totale "vuoto etico": condannarlo in toto sarebbe stato perciò sbagliato, oltre che inutile. Invece del "vuoto etico" si è prodotta, piuttosto, una grande "frammentazione etica", attraverso la moltiplicazione dei valori e dei fini cui ispirare scelte e comportamenti (dall’uguaglianza alla diversità, dall’ecologia alla pace, dalla tolleranza alla solidarietà, dall’autonomia individuale alla coesione sociale...). Sul piano morale, si è chiesto all’individuo di non uniformare più le sue scelte a principi e regole prefissati, ma di scegliere o, persino, di "produrre" egli stesso i valori e le norme cui ispirarsi (Taylor). In questo modo, l’indubbio ampliamento delle possibilità è stato spesso vanificato dalla difficoltà di individuare motivi esistenzialmente e storicamente validi cui riferire singole decisioni e scelte di vita. Così, pur intravedendo miraggi di onnipotenza, l’individuo finisce spesso per fare esperienze di impotenza, con una fuga dalle responsabilità non molto diversa dalla fuga dalla libertà descritta a suo tempo da Erich Fromm. Ma non è un destino obbligato. La Comunità di Sant’Egidio è diventata famosa nel mondo per l’impegno di pace, ma i risultati ottenuti da quella che è stata chiamata «l’Onu di Trastevere» sono il frutto di un’azione semplice svolta da gente comune. Se in passato erano le grandi Potenze a decidere la guerra e la pace – ha ricordato più volte Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità – oggi anche l’individuo comune può fare qualcosa di rilevante per la pace o per la guerra. Nella sua semplicità, tale affermazione implica che ognuno può contribuire a cambiare il mondo e che il mondo può diventare completamente diverso da come è attualmente. Ma occorre trovare la strada. Nelle situazioni complesse e ambivalenti, come quella in cui viviamo, più importante di un giudizio sicuro su uomini, idee, avvenimenti, è infatti non smarrire l’orientamento.
 La Comunità di Sant’Egidio ha cercato di seguire una bussola preziosa: l’amicizia con i poveri. Quando l’immagine del consumatore si sovrappone a tutte le altre, è facile perdere coscienza di chi è l’uomo, qual è il suo valore, quale il fondamento della sua dignità; si perde di vista, soprattutto, che cosa vuol dire umanità. Se si arriva a vantarsi quando si respinge in mare chi fugge dalla violenza, dalla fame, dalla morte, vuol dire che si è già compiuto un lungo percorso sulla strada della disumanità. Ma chi è amico dei poveri è da loro richiamato non solo alla costante debolezza di fondo della condizione umana, ma anche a ritrovare ragioni autenticamente umane per sperare, per lottare e, soprattutto, per vivere con gli altri: nelle sofferenze e nei sentimenti dei poveri è indicata la via verso il futuro, sono le loro attese a farci capire che cos’è il Regno di Dio. La Comunità di Sant’Egidio ha cercato di seguire una bussola preziosa: l’amicizia con i poveri. Quando l’immagine del consumatore si sovrappone a tutte le altre, è facile perdere coscienza di chi è l’uomo, qual è il suo valore, quale il fondamento della sua dignità; si perde di vista, soprattutto, che cosa vuol dire umanità. Se si arriva a vantarsi quando si respinge in mare chi fugge dalla violenza, dalla fame, dalla morte, vuol dire che si è già compiuto un lungo percorso sulla strada della disumanità. Ma chi è amico dei poveri è da loro richiamato non solo alla costante debolezza di fondo della condizione umana, ma anche a ritrovare ragioni autenticamente umane per sperare, per lottare e, soprattutto, per vivere con gli altri: nelle sofferenze e nei sentimenti dei poveri è indicata la via verso il futuro, sono le loro attese a farci capire che cos’è il Regno di Dio.
Su questa strada, l’Africa è entrata da tempo nel cuore della Comunità e sempre più numerosi sono gli africani che ne condividono il cammino. Potrebbe sembrare il semplice riflesso di una tendenza generale: le statistiche mostrano che ormai più della metà dei cattolici vive fuori dall’Europa (Jenkins). Ma nella scelta di Sant’Egidio per l’Africa c’è soprattutto la convinzione che «la pietra che i costruttori hanno scartato» diventerà «pietra d’angolo»: «Chi crede in essa non resterà deluso». È anche una scelta culturale e strategica – implica, infatti, che gli equilibri internazionali non possono ignorare l’Africa – ed è una scelta europeista: il legame tra Europa ed Africa è antico e profondo, il disinteresse attuale per il "continente nero" è un segno del declino europeo e della tentazione dell’Europa di «congedarsi dalla storia», come ha detto Benedetto XVI. In Africa, la Comunità ha diffuso la speranza di curare l’Aids, moltiplicando con il programma Dream le possibilità di vivere grazie alla terapia di cui da tempo dispone il mondo ricco ma che, si diceva, gli africani non sarebbero mai stati in grado di utilizzare. In Africa, Sant’Egidio ha incontrato uomini e donne di una forza straordinaria, di cui hanno bisogno non solo i loro Paesi ma il mondo intero, anche se non lo sa.
 Pur diventando profondamente africana, però, la Comunità di Sant’Egidio è rimasta anche profondamente romana. È nata a Roma ma è diventata romana soprattutto per scelta. «Non è possibile restare a Roma senza un’idea universale», ripetevano con preoccupazione gli esponenti della classe dirigente piemontese che dopo il 1870 hanno trasferito a Roma la capitale di un Regno d’Italia ancora piccolo e fragile. L’universalità di Roma è legata soprattutto al papato, un’istituzione singolare, anzi unica nella storia. Oggi il problema, però, è che pochi si chiedono il senso di questa istituzione che continua a caratterizzare in profondità l’intera Chiesa cattolica, dalla Cina agli Stati Uniti, e questo è un limite anche per chi la vorrebbe riformare. Pur diventando profondamente africana, però, la Comunità di Sant’Egidio è rimasta anche profondamente romana. È nata a Roma ma è diventata romana soprattutto per scelta. «Non è possibile restare a Roma senza un’idea universale», ripetevano con preoccupazione gli esponenti della classe dirigente piemontese che dopo il 1870 hanno trasferito a Roma la capitale di un Regno d’Italia ancora piccolo e fragile. L’universalità di Roma è legata soprattutto al papato, un’istituzione singolare, anzi unica nella storia. Oggi il problema, però, è che pochi si chiedono il senso di questa istituzione che continua a caratterizzare in profondità l’intera Chiesa cattolica, dalla Cina agli Stati Uniti, e questo è un limite anche per chi la vorrebbe riformare.
La domanda sui rapporti con il Vaticano è una delle più ricorrenti quando si parla di Sant’Egidio: è evidente che si tratta di due realtà ben distinte. Ma, a causa di una prossimità insieme storica e geografica, questa Comunità non ha potuto fare a meno di interrogarsi su un’istituzione che affida a un uomo solo il compito non di governare ma di unire e rappresentare nella sua persona più di un miliardo di credenti, come evidenziano i viaggi del Papa, da ultimo quello in Israele. Capire il papato, servire con il Papa, attraverso l’umanità di chi pro tempore lo interpreta, è un tratto spirituale e antropologico di Sant’Egidio e anche uno stimolo a cercare l’unità con chi nel Papa non si riconosce ma sul Papa non può fare a meno di interrogarsi, come i cristiani di altre confessioni. Raccogliendo l’iniziativa di un Papa, Giovanni Paolo II, la Comunità ha iniziato a condividere la fatica del dialogo con credenti di altre religioni, ebrei anzitutto, ma anche musulmani, buddhisti e tanti altri. Il papato, infatti, è una risorsa di tutti i cattolici ed è segno di un’universalità dalla quale nessun uomo e nessuna terra sono esclusi.
Agostino Giovagnoli
Le tante, buone radici della Comunità
L'alluvione del ’66 a Firenze e gli "angeli del fango", don Lorenzo Milani e la sua Barbiana, ma anche il movimento biblico e Charles de Foucauld, piccolo fratello di Gesù in mezzo ai musulmani, i gruppi di confronto e di rinnovamento giovanile come Gioventù Studentesca. Sono questi, con il Concilio Vaticano II e il rinnovamento laicale di quegli anni, le origini vicine e i precedenti di quello che è diventata la Comunità di Sant’Egidio. In sintesi: dare la parola a chi non ce l’ha, perché poi incontri anche la Parola nel cuore grande della Chiesa; e un bisogno di fedeltà evangelica scarna, assoluta, che è stata una delle anime del ’68, prima di alcune successive involuzioni. Ma se si cerca più lontano, le origini ci riportano al monachesimo antico.
C’è un filo che lega la grande esperienza del "monachesimo interiorizzato" di Evdokimov, la grande tradizione comunitaria e di impegno civile e sociale del monachesimo orientale e occidentale, nella sua accezione laicale e nell’aspirazione a un impegno integrale "davvero evangelico", e l’esperienza francescana: vivere la fraternità e la scelta di essere una stessa famiglia con i poveri, con il desiderio di cambiare il mondo con mitezza, ma anche forte impegno. Una relazione tutta speciale è proprio quella che Sant’Egidio ha con san Francesco, il giovane ricco che incontra il lebbroso e si converte, innamorato delle Scritture e della Croce. C’è inoltre un’analogia tra le grandi esperienze di rinnovamento nel post-Concilio di Trento, Gesuiti e oratoriani, e la nascita di una realtà come Sant’Egidio dopo il Vaticano II. E dentro il dna c’è san Filippo Neri, ma anche san Domenico e il suo rapporto tra Vangelo, cultura e predicazione. Poi l’amore per i giovani, la grande tradizione dei santi della carità, san Vincenzo de’ Paoli e il Cottolengo; l’inventore della scuola pubblica per i poveri, san Giuseppe Calasanzio. O la carità di un grande papa, Gregorio Magno, con il suo posto a tavola lasciato per il povero, ispirazione che torna nei pranzi di Natale della Comunità. Ma anche storia, radicamento nella tradizione e nella lezione di una Chiesa materna e misericordiosa, vasta: quella del grande patriarca Athenagoras, conoscitore del mondo e della bellezza di tutti i popoli; e quella di Giovanni XXIII, «Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri». E sempre una sola fonte e bussola: la Bibbia, guida e sorgente per ognuno, a cui tornare nella meditazione personale quotidiana e nella preghiera comune, àncora e liberazione spirituale in ogni tempo.
a.gio
Multinazionale senza confini se non quello della carità
Cinquantamila aderenti in 73 Paesi diversi: Sant’Egidio ha una struttura planetaria, un cuore profondamente romano e uno spirito evangelico universale.
Oggi la Comunità di Sant’Egidio è una realtà mondiale presente in 73 Paesi di cinque continenti. Il numero dei membri aumenta regolarmente. Sono oltre 50 mila gli aderenti, anche se è molto più ampio il numero di quanti sono coinvolti nel servizio ai poveri, nella preghiera, in una vicinanza spirituale in vario modo. Gratuità, amicizia, dialogo, mezzi poveri per umanizzare il mondo. E poi il Vangelo al centro, la Bibbia, amata, la liturgia e la preghiera serale e personale, «prima opera della Comunità». Cristiani laici che prendono sul serio il Vangelo tutto intero come propria vocazione: è così da più di quarant’anni, fino a diventare una proposta antropologica e spirituale per un’intera generazione di laici, dopo il Concilio Vaticano II. Un carisma nato a Roma, di cui risente nella sua portata universale: «Voi, non vi siete posto altro confine che quelli della carità», disse loro Giovanni Paolo II. È la necessità interiore di collaborare al ministero di «presiedere nella carità» senza porre confini di età, di luogo, di cultura. Una scelta che trova conferma anche nell’organizzazione della Comunità: nel consiglio di Presidenza, rinnovato nei mesi scorsi, sono presenti membri di undici nazionalità, anche se il cuore resta italiano.
 Dal 1986 Sant’Egidio è riconosciuta dalla Santa Sede come Associazione pubblica di laici. La basilica di Santa Maria in Trastevere e quella di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, luogo memoriale-ecumenico dei martiri contemporanei, ospitano la preghiera serale nel centro storico di Roma, quella della Comunità "più anziana". E l’attualità di un impegno francescano moderno è quello che sottolineava Giovanni Paolo II durante la visita del 1993 a Santa Maria in Trastevere. Globalizzare la solidarietà, ma anche tradurre il Vangelo, l’amicizia, in una forza di riconciliazione e di pace: è una sfida interiore per ogni membro della Comunità, e una pratica comune che ha portato Sant’Egidio a essere un soggetto originale, per alcuni aspetti unico, nella sua capacità di pace, di vera e propria diplomazia dal basso. Dal 1986 Sant’Egidio è riconosciuta dalla Santa Sede come Associazione pubblica di laici. La basilica di Santa Maria in Trastevere e quella di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, luogo memoriale-ecumenico dei martiri contemporanei, ospitano la preghiera serale nel centro storico di Roma, quella della Comunità "più anziana". E l’attualità di un impegno francescano moderno è quello che sottolineava Giovanni Paolo II durante la visita del 1993 a Santa Maria in Trastevere. Globalizzare la solidarietà, ma anche tradurre il Vangelo, l’amicizia, in una forza di riconciliazione e di pace: è una sfida interiore per ogni membro della Comunità, e una pratica comune che ha portato Sant’Egidio a essere un soggetto originale, per alcuni aspetti unico, nella sua capacità di pace, di vera e propria diplomazia dal basso.
Capita così che confini geografici, nazionali ed etnici, che spesso separano il mondo, a Sant’Egidio si sciolgano. Nel Ruanda del genocidio tra hutu e tutsi, ad esempio, le comunità sono composte da giovani delle due etnie, fratelli tra loro, senza frontiere e senza muri. In una stagione nella quale si esaltano i confini e le differenze, le diverse comunità di Sant’Egidio vogliono testimoniare l’esistenza di un destino diverso, di apertura al mondo e di appartenenza a un’unica famiglia umana. Da Roma a San Salvador, dal Camerun al Belgio, dall’Ucraina all’Indonesia, neppure la più giovane delle comunità può considerarsi tanto piccola o debole da non poter pregare, aiutare i poveri, testimoniare il Vangelo e aiutare la costruzione della pace e l’umanizzazione del mondo. Ma al tempo stesso Sant’Egidio è sempre locale. Le comunità, ovunque nascano, sono autoctone, cosa che permette un’inculturazione evangelica naturale: in Indonesia, il più grande Paese islamico del mondo, le piccole comunità di Sant’Egidio aiutano i bambini della minoranza cinese, fanno scuola ai ragazzi musulmani e si occupano dei poveri che vivono per la strada. E nel Kivu, regione del Congo dai conflitti interminabili, le giovani comunità aiutano i poveri, i bambini, e i profughi nei campi di Mugunga.
 Alcuni tratti ed eventi ritornano ovunque. Accade per esempio con il pranzo di Natale: ogni 25 dicembre, a ogni latitudine, le Comunità radunano i poveri che aiutano durante l’anno per un pranzo dal tono familiare, che spesso viene offerto in una chiesa. Accade con gli anziani negli istituti tedeschi o con i barboni musulmani in Pakistan e in Indonesia; ma anche nelle carceri africane, dove lo Stato non passa cibo ai detenuti, e se non si ha una "famiglia" che ti aiuta sei condannato a morire di fame. Alcuni tratti ed eventi ritornano ovunque. Accade per esempio con il pranzo di Natale: ogni 25 dicembre, a ogni latitudine, le Comunità radunano i poveri che aiutano durante l’anno per un pranzo dal tono familiare, che spesso viene offerto in una chiesa. Accade con gli anziani negli istituti tedeschi o con i barboni musulmani in Pakistan e in Indonesia; ma anche nelle carceri africane, dove lo Stato non passa cibo ai detenuti, e se non si ha una "famiglia" che ti aiuta sei condannato a morire di fame.
Altro tratto che rende nota la Comunità sono le "mediazioni" per la pace in conflitti decennali, come in Mozambico, Costa d’Avorio, Burundi e Guatemala. O anche la campagna per una moratoria mondiale di tutte le esecuzioni capitali. Oppure l’innovativo progetto Dream, che prevede cure di eccellenza per l’Aids in Africa, con 75 mila persone che oltre alle medicine ricevono anche sostegno alimentare, testimoniando che è possibile tornare a vivere e convincendo altri a curarsi. Non a caso, nel suo recente viaggio in Africa, Benedetto XVI ha citato Sant’Egidio rilevando che «la realtà più efficiente, più presente sul fronte della lotta contro l’Aids sia proprio la Chiesa cattolica, con i suoi movimenti».
 Al centro del carisma della Comunità resta il dialogo ecumenico e interreligioso, nello "spirito di Assisi" inaugurato da Giovanni Paolo II e confermato da Benedetto XVI anche nella sua recente Lettera ai vescovi: «La necessità che tutti coloro che credono in Dio cerchino insieme la pace, tentino di avvicinarsi gli uni agli altri, per andare insieme, pur nella diversità delle loro immagini di Dio, verso la fonte della luce – è questo il dialogo interreligioso». Su questo cammino la prossima tappa è l’incontro che si svolge dal 6 all’8 di questo mese di settembre, a Cracovia, dove si farà memoria dei 70 anni dalla guerra mondiale e della grande intuizione di Papa Wojtyla. Al centro del carisma della Comunità resta il dialogo ecumenico e interreligioso, nello "spirito di Assisi" inaugurato da Giovanni Paolo II e confermato da Benedetto XVI anche nella sua recente Lettera ai vescovi: «La necessità che tutti coloro che credono in Dio cerchino insieme la pace, tentino di avvicinarsi gli uni agli altri, per andare insieme, pur nella diversità delle loro immagini di Dio, verso la fonte della luce – è questo il dialogo interreligioso». Su questo cammino la prossima tappa è l’incontro che si svolge dal 6 all’8 di questo mese di settembre, a Cracovia, dove si farà memoria dei 70 anni dalla guerra mondiale e della grande intuizione di Papa Wojtyla.
Augusto D'Angelo
Volontariato, la grande risorsa
Per dare corpo a tutte le sue attività Sant’Egidio raccoglie numerosi fondi in vario modo che vengono così distribuiti: il 95 per cento delle risorse va per i poveri attraverso assistenza, mense, centri di distribuzione di generi alimentari e vestiti, centri sanitari (il progetto Dream assorbe più di metà del bilancio, nonostante il lavoro volontario di tutti i responsabili), progetti per uscire dall’emergenza (dal Darfur al Kivu, dai tifoni in America centrale allo tsunami in Asia), l’assistenza domiciliare per anziani e disabili. Il 5 per cento delle spese è assorbito dalle strutture indispensabili ad assicurare il coordinamento (altre organizzazioni internazionali assorbono per questo scopo dal 20 all’80 per cento). I donatori sono privati e istituzioni. Si va dalle collette davanti alle parrocchie alle fondazioni bancarie, dagli enti locali all’Unione europea alla Cei, dalle donazioni in natura per l’allestimento dei pranzi di Natale a quelle delle associazioni, dall’offerta mensile dell’anziano che devolve 10 euro della sua pensione per i poveri, a quanti offrono il loro contributo attraverso il sito internet (www.santegidio.org – tel. 06/58.56.61). La Comunità rileva che la difficoltà è quella di allargare i sostenitori per prevenire contraccolpi in tempi di crisi economica, anche perché Sant’Egidio rimane fedele ai poveri nel tempo, mentre i finanziamenti nazionali e internazionali sono in genere limitati e non ripetibili. Il vero tesoro di Sant’Egidio, comunque, continua a essere la gratuità con la quale migliaia di uomini e donne dedicano il proprio tempo a prendersi cura degli altri, con un vero e proprio effetto moltiplicatore delle risorse: basti pensare che a Roma solo un decimo dell’attività reale è coperta da finanziamenti pubblici o privati.
a.d’a.
L'incontro con i poveri un'avventura quotidiana
Via Dandolo, via Anicia, Tor Bella Monaca: una strana mappa di Roma, che neanche molti abitanti della capitale conoscono. Segna i mille punti in cui sorgono le attività di volontariato promosse da Sant’Egidio. E ogni punto racconta una storia, un dramma, ma anche la rinascita della speranza.
La porta è aperta a qualunque ora del giorno. Nel porticato mamme giovanissime e piccoli rom aspettano turisti e pellegrini con discrezione. In sacrestia un uomo senza fissa dimora recupera i documenti che aveva lasciato in custodia, prima di essere ricoverato d’urgenza per l’ennesimo abuso di alcol. Sono di casa a Santa Maria in Trastevere. Matteo, come qui tutti chiamano don Zuppi, il parroco, li saluta chiamandoli per nome. Il viaggio tra le "opere" della Comunità di sant’Egidio ha come bussola il campanile romanico che domina una delle piazza più famose di Roma. È qui a Trastevere che dagli anni ’70, con tenacia e abilità, la Comunità è riuscita a mantenere il suo baricentro, pur continuando a far crescere gruppi e attività nelle periferie più difficili e lontane, di Roma e del mondo.
 La filosofia "mantenere i poveri al centro" ha significato comprare locali, chiederli in comodato, affittarli, avviare attività commerciali in questo quartiere, dove molti "santegidini" hanno messo radici anche con le loro famiglie. È una mappa diversa che al turista e agli stessi romani sfugge: la basilica, dove don Zuppi – e prima di lui don Vincenzo Paglia, attuale vescovo di Terni e direttore dell’ufficio ecumenismo della Cei – integra i percorsi parrocchiali ordinari con l’attività ecumenica, pastorale e caritativa della Comunità; il complesso di Sant’Egidio, alle spalle di Santa Maria in Trastevere, che nelle sale affrescate e nei giardini interni accoglie capi di Stato e patriarchi, politici e cardinali. E, nella stessa piazzetta, la Trattoria degli Amici, dove lavorano persone diversamente abili. E poi via Dandolo, sede della mensa e della scuola di italiano; via Anicia, dove italiani, stranieri e zingari possono contare su un ascolto e un aiuto qualificato; Palazzo Leopardi in piazza Santa Maria, con un centro multietnico per minori e corsi di formazione per ragazzi disabili; poco lontano, salendo la collina del Gianicolo, le residenze protette per anziani... Un elenco che potrebbe continuare. Ma più interessante della geografia delle pietre, è forse la mappa delle relazioni. Le storie, i volti, le situazioni che permettono di capire come "opere" di per sé non originalissime – mense, centri di ascolto, scuole di italiano... – assumendo il marchio Sant’Egidio siano entrate in un progetto di più ampio respiro. In una filosofia che, come per ogni movimento, ha alcune parole d’ordine: comunità, amici, poveri. La filosofia "mantenere i poveri al centro" ha significato comprare locali, chiederli in comodato, affittarli, avviare attività commerciali in questo quartiere, dove molti "santegidini" hanno messo radici anche con le loro famiglie. È una mappa diversa che al turista e agli stessi romani sfugge: la basilica, dove don Zuppi – e prima di lui don Vincenzo Paglia, attuale vescovo di Terni e direttore dell’ufficio ecumenismo della Cei – integra i percorsi parrocchiali ordinari con l’attività ecumenica, pastorale e caritativa della Comunità; il complesso di Sant’Egidio, alle spalle di Santa Maria in Trastevere, che nelle sale affrescate e nei giardini interni accoglie capi di Stato e patriarchi, politici e cardinali. E, nella stessa piazzetta, la Trattoria degli Amici, dove lavorano persone diversamente abili. E poi via Dandolo, sede della mensa e della scuola di italiano; via Anicia, dove italiani, stranieri e zingari possono contare su un ascolto e un aiuto qualificato; Palazzo Leopardi in piazza Santa Maria, con un centro multietnico per minori e corsi di formazione per ragazzi disabili; poco lontano, salendo la collina del Gianicolo, le residenze protette per anziani... Un elenco che potrebbe continuare. Ma più interessante della geografia delle pietre, è forse la mappa delle relazioni. Le storie, i volti, le situazioni che permettono di capire come "opere" di per sé non originalissime – mense, centri di ascolto, scuole di italiano... – assumendo il marchio Sant’Egidio siano entrate in un progetto di più ampio respiro. In una filosofia che, come per ogni movimento, ha alcune parole d’ordine: comunità, amici, poveri.
È un brutto martedì. È in corso uno di quegli scioperi minori, che colgono alla sprovvista i meno attenti. Le prima vittime sono gli anziani. Come la signora che arriva da Borgata Ottavia trafelata e inviperita. Ritira il numeretto e finalmente si rilassa, nella sala d’attesa dalle sedie di plastica blu, in via Anicia al numero 6c. Un viaggio di un’ora per due chili di pasta, un pacco di zucchero, latte e biscotti. «Negli anni i destinatari del servizio sono cambiati. È cresciuta la presenza straniera. Tra gli italiani è aumentata la domanda di sostegno alimentare», spiega Francesca Zuccari, la responsabile dei servizi relativi alla mensa. Assistente sociale, Francesca ha conosciuto la Comunità quando frequentava il liceo Virgilio. «Questo non è un impegno da fare durante il tempo libero, è senso della vita. L’incontro con i poveri è un’avventura. A volte basta poco per aprire spazi di speranza».
Il centro di ascolto sorge nei locali di un’antica congregazione di carità, che vennero dati all’assistenza pubblica e infine in comodato alla Comunità in cambio del restauro. Oggi via Anicia è un punto di riferimento per i senza fissa dimora, un posto dove puoi andare per avere una prima assistenza informativa e legale di "bassa soglia", recuperare un po’ di viveri e soprattutto capire come districarsi tra le maglie della burocrazia italiana. Tanti, soprattutto anziani, dice Zuccari, hanno scarsa dimestichezza con i servizi sociali e uno dei compiti del centro è proprio favorire il raccordo tra il cittadino meno abbiente e la pubblica amministrazione. «Spesso si vergognano di chiedere aiuto, è molto alta la richiesta di medicinali non coperti dal servizio sanitario nazionale».
 Chiunque si trovi in difficoltà può varcare la soglia di questo palazzetto situato sulla sponda più tranquilla di Trastevere, non lontano dalla basilica di Santa Cecilia. A piano terra, oltre al centro di ascolto, docce, servizio guardaroba, lavanderia, assistenza medica e parrucchiere. Al primo piano la casa di accoglienza "San Francesco", una decina di posti letti per l’emergenza. «Per chi vive in strada non ci sono servizi gratuiti. E, checché se ne dica, a nessuno piace essere sporco». Così, a seconda dei giorni, in sala d’attesa trovi italiani, stranieri, zingari, in fila per una doccia e una tintura di capelli, per una rinfrescatina allo smalto e la scelta di un nuovo abbigliamento-usato. Persone che negli anni hanno imparato a fidarsi dei volontari della Comunità. Spesso, infatti, via Anicia è soltanto la seconda tappa di un incontro fatto altrove, perché «il rapporto con la povertà nasce dalla strada», spiega Francesca. Chiunque si trovi in difficoltà può varcare la soglia di questo palazzetto situato sulla sponda più tranquilla di Trastevere, non lontano dalla basilica di Santa Cecilia. A piano terra, oltre al centro di ascolto, docce, servizio guardaroba, lavanderia, assistenza medica e parrucchiere. Al primo piano la casa di accoglienza "San Francesco", una decina di posti letti per l’emergenza. «Per chi vive in strada non ci sono servizi gratuiti. E, checché se ne dica, a nessuno piace essere sporco». Così, a seconda dei giorni, in sala d’attesa trovi italiani, stranieri, zingari, in fila per una doccia e una tintura di capelli, per una rinfrescatina allo smalto e la scelta di un nuovo abbigliamento-usato. Persone che negli anni hanno imparato a fidarsi dei volontari della Comunità. Spesso, infatti, via Anicia è soltanto la seconda tappa di un incontro fatto altrove, perché «il rapporto con la povertà nasce dalla strada», spiega Francesca.
 Sono tanti gli incontri che varrebbe la pena di raccontare. Alcuni nomi, però, hanno letteralmente segnato la storia della Comunità. Il primo è quello di Ali Jama, un giovane somalo che non era stato riconosciuto rifugiato politico dall’Italia e viveva per strada. Nel 1979, sui gradini della chiesa di Santa Maria della Pace, a due passi da piazza Navona, gli venne dato fuoco e morì per le ustioni riportate. «La storia ci colpì. Chiedemmo a Giovanni Paolo II di parlarne nell’Angelus. E da lì è iniziata la nostra attenzione agli immigrati». Sono tanti gli incontri che varrebbe la pena di raccontare. Alcuni nomi, però, hanno letteralmente segnato la storia della Comunità. Il primo è quello di Ali Jama, un giovane somalo che non era stato riconosciuto rifugiato politico dall’Italia e viveva per strada. Nel 1979, sui gradini della chiesa di Santa Maria della Pace, a due passi da piazza Navona, gli venne dato fuoco e morì per le ustioni riportate. «La storia ci colpì. Chiedemmo a Giovanni Paolo II di parlarne nell’Angelus. E da lì è iniziata la nostra attenzione agli immigrati».
Il centro di ascolto nasce nell’82, e l’anno successivo viene affiancato da una distribuzione itinerante di cene. Ancora una volta è una storia che accende l’attenzione su un dramma che coinvolge tanti e sollecita una risposta. Alla stazione Termini un’anziana si sente male: la vita raccolta in buste di plastica, è una "barbona", ha i pidocchi. L’autoambulanza che arriva sul posto si rifiuta di soccorrerla. Modesta Valenti muore poco dopo. Oggi al suo nome è dedicata una via virtuale che, su proposta della Comunità, il comune di Roma ha eletto a residenza anagrafica per chi è senza casa (prassi a rischio, con le nuove leggi sulla sicurezza). E Modesta, nell’immaginario del popolo della strada, è ormai una cara amica. «Dopo la sua morte decidemmo di dar vita al servizio di cene itineranti, che è continuato anche quando nell’88 è nata la mensa».
L'appuntamento è alle 20.30 in via Dandolo, davanti alle mensa. Susanna, Giovanni e Francesco sono la "squadra di Ponte Mammolo". Un’architetto, un amministratore e un professore di storia, che da una ventina di anni, ogni martedì sera, sono attesi negli angoli della città dove trovano casa i senza casa. Marciapiedi, sottopassaggi, parcheggi abbandonati ospitano giacigli e baracche. Tutto, anche un triangolo di asfalto tra i cassonetti e le strade a scorrimento veloce, può diventare riparo per chi non ha più nulla da perdere. «Questo servizio è nato per incontrare il bisogno più estremo, quelli che non vanno alla mensa né al centro di ascolto», spiega Susanna.
Carichiamo in macchina le buste con i panini preparati dal gruppo che si occupa di questa zona. L’organizzazione è complicata ma ferrea: le otto squadre della Comunità che almeno una volta a settimana coprono Roma e periferia con la cena itinerante sono supportati da altrettanti gruppi che la preparano. Panini, frutta e una bibita, ma d’inverno anche una minestra calda. Un migliaio di persone in tutto, con distribuzione in un centinaio di punti. «Alcuni non sappiamo dove dormono. Ma il martedì c’è una sorta di appuntamento. L’importante è essere fedeli, non mancare mai. Dare la sicurezza che c’è qualcuno che ti dà una mano», spiega Francesco. Anche perché il pasto è solo un pretesto: se c’è freddo arriva la coperta, se qualcuno è malato lo si porta in ospedale. Una rete di supporto che negli anni si è intrecciata al lavoro di parrocchie e gruppi di volontariato che sono sul territorio.
 L’odore di frittata dal bagagliaio accompagna la conversazione mentre ci dirigiamo nella zona di Pietralata, in un’area individuata ai tempi del Giubileo come parcheggio periferico per i pullman dei pellegrini. Proprio con il Giubileo e con l’operazione Grandi Stazioni è cominciato l’esodo dei senza fissa dimora dal centro verso le periferie. Risanata Termini, interrati alcuni sottopassaggi che avevano dato riparo ai senza tetto durante i periodi più freddi, il composito popolo della strada ha trovato altre sistemazioni. L’odore di frittata dal bagagliaio accompagna la conversazione mentre ci dirigiamo nella zona di Pietralata, in un’area individuata ai tempi del Giubileo come parcheggio periferico per i pullman dei pellegrini. Proprio con il Giubileo e con l’operazione Grandi Stazioni è cominciato l’esodo dei senza fissa dimora dal centro verso le periferie. Risanata Termini, interrati alcuni sottopassaggi che avevano dato riparo ai senza tetto durante i periodi più freddi, il composito popolo della strada ha trovato altre sistemazioni.
A via delle Messi d’Oro, tra la Tiburtina e la Nomentana, sorge una baraccopoli che la recente potatura di alberi svela in tutta la sua geometria: le centinaia di baracche costruite nel tempo vanno dalla roulotte alla costruzione di mattoni, dalla tenda alle lamiere. C’è la zona degli etiopi, quella degli ecuadoregni, il blocco degli indiani e poi quello ex sovietico. «Buona parte delle persone che abitano qui hanno un regolare permesso di soggiorno. Alcuni sono rifugiati politici. Molte donne lavorano come colf o badanti durante il giorno, gli uomini per lo più sono muratori o vendono al dettaglio», spiega Giovanni. Si tratta, insomma, di chi a Roma riesce a sopravvivere ma non può permettersi il lusso di un affitto. E così, tra bombole del gas e allacciamenti elettrici fatti alla bell’e meglio, c’è gente che vive qui da anni. Come Leonid, che dice di essere vicecomandante dell’Armata rossa e di aver lavorato sui sommergibili nucleari. O Dobro, montenegrino, apolide, uno dei primi a mettere su casa qui, 17 anni fa. O Lucia, ucraina, 20 anni, operata di tumore a Roma e trasferitasi con i genitori per poter continuare a fare la chemioterapia che in patria non le era accessibile. In strada sono in attesa una decina di persone. Giovani nordafricani, eritrei, uomini dell’Est. Salutano, prendono panini anche per gli amici, bevono un sorso di tè caldo, chiedono qualche informazione, in disparte. All’ingresso del campo, nel buio della notte, si intravede una bandiera della pace.
Si risale in macchina per la tappa successiva. Sotto il cavalcavia della Tangenziale Est, a Tiburtina, Rajid, Aldo ed Edi hanno dato fondo anche all’ultimo goccio. Riescono comunque a riconoscere gli amici, accettano un panino. Il giovane marocchino chiede a Susanna un aiuto per tornare ad Agadir, così «la smetto di fare sciocchezze», dice. Ha provato anche il carcere, è già vecchio. Edi, sdraiato in terra su una logora coperta militare tra le cartacce, divide il panino con la cagnetta e poi chiede se abbiamo un detergente per cani. Ha il corpo coperto di vecchie ustioni: una decina di anni fa dormiva poco lontano. Qualcuno gli diede fuoco, riuscì a cavarsela. Uscito dall’ospedale è tornato qui. Anche Mariano, poco più avanti, a piazzale Labicano, è una presenza conosciuta. Il Comune qualche anno fa ha messo una cancellata per impedire l’accesso allo spazio riparato sotto il cavalcavia. Gli altri senza fissa dimora sono andati via tutti. Lui ha semplicemente spostato il suo giaciglio più avanti, sul marciapiede, alle intemperie. Quando passiamo non c’è. Lasciamo un panino e una bottiglia di thé caldo sotto gli stracci bagnati dalla pioggia.
 Torniamo a Trastevere. Il popolo della mensa fa il suo ingresso alle 17 in punto, appena si spalanca il portone verde di via Dandolo 10. Molti sono a digiuno. L’anziana con il carrello della spesa pieno di buste di plastica, un papà slavo con il figlio, una famiglia eritrea al completo, una coppia di anziani, giovani nordafricani, donne dell’Est... Gli italiani si dirigono a destra, a sinistra gli stranieri. La divisione è stata fatta per andare incontri ai primi: molti sono anziani, alcuni vengono qui da anni, si sono sentiti spinti in un angolo dalla sempre più numerosa presenza straniera. «Lo scorso anno abbiamo registrato 158 mila ingressi: 13 mila gli italiani, 145 mila gli stranieri, di circa 150 nazionalità», racconta Francesca Zuccari. Nelle ampie sale dove un tempo giravano le macchine di una tipografia di Lotta Continua, oggi ci sono tavoli apparecchiati con cura e il bancone della mensa. E poi lo spazio per i libri – la piccola biblioteca dà in prestito gialli, i più richiesti, ma anche Montanelli, Malerba, Ende e Bevilacqua – e quello per il ritiro della posta, perché molti, anche alle famiglie all’estero, danno via Dandolo come indirizzo per la loro corrispondenza. Torniamo a Trastevere. Il popolo della mensa fa il suo ingresso alle 17 in punto, appena si spalanca il portone verde di via Dandolo 10. Molti sono a digiuno. L’anziana con il carrello della spesa pieno di buste di plastica, un papà slavo con il figlio, una famiglia eritrea al completo, una coppia di anziani, giovani nordafricani, donne dell’Est... Gli italiani si dirigono a destra, a sinistra gli stranieri. La divisione è stata fatta per andare incontri ai primi: molti sono anziani, alcuni vengono qui da anni, si sono sentiti spinti in un angolo dalla sempre più numerosa presenza straniera. «Lo scorso anno abbiamo registrato 158 mila ingressi: 13 mila gli italiani, 145 mila gli stranieri, di circa 150 nazionalità», racconta Francesca Zuccari. Nelle ampie sale dove un tempo giravano le macchine di una tipografia di Lotta Continua, oggi ci sono tavoli apparecchiati con cura e il bancone della mensa. E poi lo spazio per i libri – la piccola biblioteca dà in prestito gialli, i più richiesti, ma anche Montanelli, Malerba, Ende e Bevilacqua – e quello per il ritiro della posta, perché molti, anche alle famiglie all’estero, danno via Dandolo come indirizzo per la loro corrispondenza.
Il vialetto che conduce alla mensa, e nei locali superiori alla scuola di italiano, è uno spazio piacevole dove sostare, con le panchine sotto i rampicanti e le pareti rallegrate da murales. Chi arriva segue con dimestichezza la trafila che prevede il ritiro di un biglietto di ingresso e la firma del registro (ogni pasto va documentato per ricevere i contributi comunali). Ai nuovi arrivati è richiesta la compilazione di una scheda nominativa, non l’esibizione del documento di identità. Volontari di ogni nazionalità – giovani, religiosi di varie congregazioni, seminaristi – servono ai tavoli senza fretta. Sono 80 a turno, e spesso capita che chi arriva alle 16 lasci poi il posto a chi, finito il lavoro, dà il cambio per il turno delle 18. Ogni tavolo ha il suo addetto, e nel tempo la consuetudine diventa anche sottile filo di amicizia. I pasti preconfezionati prevedono un menù vario, da cui sono esclusi vino, maiale e aceto. «Qui viene gente da tutta Roma, di nazionalità e culture diverse. A tutti diciamo chi siamo e perché facciamo questo servizio. Per i musulmani è importante sapere che siamo cristiani ma non facciamo proselitismo», dice Zuccari.
Le amicizie nate intorno alla mensa hanno spinto negli anni a creare altri servizi, come il volontariato in carcere (a Regina Coeli, Rebibbia e al minorile) e la visita ai malati di Aids all’ospedale Spallanzani. È nata così anche l’idea di celebrare insieme momenti di festa: il pranzo di Natale nella basilica di Santa Maria in Trastevere, o la scampagnata del Primo maggio. Ogni giorno a mensa si festeggiano i compleanni dei vari ospiti, e i saloni, durante il Ramadan o le festività ortodosse, diventano spazi comunitari per celebrare alcune ricorrenze degli ospiti di altre fedi o confessioni religiose. Su tutti, all’ingresso della mensa, regna il bassorilievo di gesso e cemento dedicato a Modesta Valenti, che per un periodo è stato esposto alla stazione Termini: la donna è accasciata a terra, i barellieri vanno via, i viaggiatori la evitano e solo un bambino si gira a guardarla con affetto.
 l Paese dell’arcobaleno ha strade e paesaggi disegnati dai ragazzi. Ha i colori del sogno e la concretezza di un progetto: un mondo più giusto e più pulito, senza guerre e divisioni, dove gli anziani e i diversi si sentano a casa e persone violente non rubino l’infanzia ai bambini. Il Paese dell’arcobaleno ha sentieri invisibili che attraversano il centro e le periferie, e passa per le Scuole della pace dove bambini di etnie, lingue e religioni diverse imparano a convivere, a studiare, a divertirsi insieme, e a rendersi utili per i meno fortunati. Il Paese dell’arcobaleno è il manifesto-proposta per i più piccoli della Comunità, ed è affisso anche qui, in via delle Galline Bianche, zona Labaro-Prima Porta, periferia nord di Roma. l Paese dell’arcobaleno ha strade e paesaggi disegnati dai ragazzi. Ha i colori del sogno e la concretezza di un progetto: un mondo più giusto e più pulito, senza guerre e divisioni, dove gli anziani e i diversi si sentano a casa e persone violente non rubino l’infanzia ai bambini. Il Paese dell’arcobaleno ha sentieri invisibili che attraversano il centro e le periferie, e passa per le Scuole della pace dove bambini di etnie, lingue e religioni diverse imparano a convivere, a studiare, a divertirsi insieme, e a rendersi utili per i meno fortunati. Il Paese dell’arcobaleno è il manifesto-proposta per i più piccoli della Comunità, ed è affisso anche qui, in via delle Galline Bianche, zona Labaro-Prima Porta, periferia nord di Roma.
È un quartiere di case popolari, poco lontano dalle rive dell’Aniene, zona di piena in tempi di nubifragi e di zanzare. Palazzoni abitati da molti stranieri: latinoamericani, slavi, sudanesi e maghrebini. «Molti bambini non parlano italiano. Aiutiamo l’integrazione in un quartiere difficile», spiega Silvia Giancaterino. Ha 33 anni e 15 anni fa ha iniziato a fare la volontaria alla "scuola popolare", come allora si chiamava. Le Scuole della pace, spiega, sono un’evoluzione di quel cammino: a Roma sono presenti in 12 quartieri, quelle più vicine ai campi zingari accolgono i bambini rom, ma «l’attenzione è sempre a non ghettizzare». Mentre chiacchieriamo, Celine e Nemes, tunisine, Egidio, rumeno, e Chiara, equadoregna, sono alle prese con addizioni, sottrazioni e complemento oggetto. Sarah e la sorellina Safé disegnano. Si fanno i compiti per le vacanze e nel frattempo ci si prepara alla merenda da consumare insieme. Due volte a settimana questo locale a piano terra, dato dal municipio, su cui sventola la bandiera arcobaleno con la colomba della pace, simbolo di Sant’Egidio, accoglie da 30 a 40 bambini. I più grandi, quelli della scuola media, la domenica vanno a visitare gli anziani di una vicina casa di cura. Tutti durante l’anno preparano il "Rigiocattolo": la raccolta di giocattoli usati – nelle scuole, nelle parrocchie e nei palazzi – da rivendere in mercatini rionali per aiutare i bambini africani nell’ambito del progetto Dream. «Diventano entusiasti, convincono genitori e maestri», dice Silvia, che si è recata più volte in Malawi per portare gli aiuti raccolti dai piccoli romani. Alle pareti alcuni disegni ispirati a un fatto di cronaca di cui i ragazzi hanno discusso: Yaguine e Fodé, morti nella stiva di un aereo dove si erano nascosti per lasciare la Guinea e venire a studiare in Europa.
È uno spicchio di mondo racchiuso tra quattro pareti. Ucraini e brasiliani, algerini e afgani, russi e rumeni, islandesi e colombiani: in trent’anni quasi 40 mila persone sono passate per i corsi di italiano organizzati da Sant’Egidio. «All’inizio si era partiti per aiutare le donne di Capoverde, analfabete, con la scuola elementare. Poi si è continuato con le medie, le superiori... E intanto la domanda cresceva», racconta Daniela Pompei, sociologa, responsabile dell’area immigrazione. Ai corsi di lingua, che oggi raggiungono i livelli più alti e permettono di ottenere un titolo con certificazione europea, si sono aggiunti i corsi di formazione per mediatori culturali e la produzione di sussidi scolastici per i vari livelli di apprendimento della lingua. I testi partono da situazioni di vita concreta legate al contesto italiano: «Il sistema sanitario, i rapporti badanti-anziani, la Fiat. E poi ci sono alcune unità didattiche che ritornano a ogni livello: il 16 ottobre di Roma, la memoria delle deportazioni, il capitolo sul razzismo, con Martin Luther King e Rosa Parks, o la non violenza con Ghandi».
 Daniela, che fa parte della Comunità dal ’75, racconta come anche certe scelte di impegno con gli stranieri siano nate da alcuni incontri: quello con Jerry Essan Masslo, sudafricano arrivato in Italia per sfuggire le persecuzioni segregazioniste, per esempio, che «fu ospitato dalla Comunità presso la casa di accoglienza "La tenda di Abramo"». La morte violenta di Masslo, ucciso sul litorale domizio dove era andato a lavorare per la raccolta di pomodori, fece cambiare la legge sull’immigrazione. E costrinse anche le associazioni, laiche e cattoliche, a lavorare in rete, intorno a tavoli che ancora oggi discutono e fanno proposte sulle politiche migratorie del nostro Paese. Da circa dieci anni alcuni stranieri che gravitano intorno alla scuola si ritrovano nel movimento "Genti di pace": «Sono circa 15 mila persone, di tutte le nazionalità e religioni, con le quali ci si vede ogni mese in sedi diverse dove la Comunità è presente». La collaborazione alle attività della scuola, l’aggiornamento sulle nuove leggi, la discussione di fatti di cronaca, l’organizzazione di feste di quartiere sono alcuni degli argomenti delle assemblee. «Genti di pace», spiega Daniela, «è la parte popolare di "Uomini e religioni"», l’incontro annuale che riunisce i leaders delle diverse tradizioni di fede. «L’amore per la pace», dice il manifesto, «ci fa riconoscere tutti, nessuno escluso, come fratelli e sorelle figli di un unico Dio, anche se diversi per lingua, cultura o religione». Daniela, che fa parte della Comunità dal ’75, racconta come anche certe scelte di impegno con gli stranieri siano nate da alcuni incontri: quello con Jerry Essan Masslo, sudafricano arrivato in Italia per sfuggire le persecuzioni segregazioniste, per esempio, che «fu ospitato dalla Comunità presso la casa di accoglienza "La tenda di Abramo"». La morte violenta di Masslo, ucciso sul litorale domizio dove era andato a lavorare per la raccolta di pomodori, fece cambiare la legge sull’immigrazione. E costrinse anche le associazioni, laiche e cattoliche, a lavorare in rete, intorno a tavoli che ancora oggi discutono e fanno proposte sulle politiche migratorie del nostro Paese. Da circa dieci anni alcuni stranieri che gravitano intorno alla scuola si ritrovano nel movimento "Genti di pace": «Sono circa 15 mila persone, di tutte le nazionalità e religioni, con le quali ci si vede ogni mese in sedi diverse dove la Comunità è presente». La collaborazione alle attività della scuola, l’aggiornamento sulle nuove leggi, la discussione di fatti di cronaca, l’organizzazione di feste di quartiere sono alcuni degli argomenti delle assemblee. «Genti di pace», spiega Daniela, «è la parte popolare di "Uomini e religioni"», l’incontro annuale che riunisce i leaders delle diverse tradizioni di fede. «L’amore per la pace», dice il manifesto, «ci fa riconoscere tutti, nessuno escluso, come fratelli e sorelle figli di un unico Dio, anche se diversi per lingua, cultura o religione».
Sono artisti, cuochi, sommelier. Sono autori di mostre di pittura e aiutanti nelle cucine di grandi chef. Sono sostenitori del progetto Dream in Africa e attivisti nella campagna contro la pena di morte. Sono gli "amici", i diversamente abili. Nel ’73, l’incontro con le persone disabili significa per la Comunità la conoscenza di grandi solitudini e altrettanto grandi domande di amicizia. Nasce la consapevolezza di dover agire su più fronti: rompere l’isolamento dell’istituto, favorire l’inserimento scolastico, lavorativo, ecclesiale. In concreto, racconta Antonella Antezza, docente di Lettere che coordina l’intero campo di attività per i disabili, questo ha portato all’«apertura di tre case-alloggio nel quartiere Monteverde, a promuovere attività di sostegno all’apprendimento, soprattutto nelle zone di periferia, a offrire la possibilità di mettersi sul mercato del lavoro». E a progettare dei sussidi liturgici con una metodologia particolare e un ricco corredo iconografico per aiutare da un lato "gli amici" ad avvicinarsi ai sacramenti e dall’altro le comunità parrocchiali a capire che non solo è possibile ma è un arricchimento reciproco la comunicazione del Vangelo ai diversamente abili.
Nasce così Il Vangelo per tutti, con prefazione di monsignor Ravasi: Daniela, che ha trascorso 30 anni in istituto, me lo regala durante la visita alla casa-alloggio di Monteverde. «Con questa casa ho realizzato il mio sogno», racconta. Ogni stanza è personalizzata: Gabriele ha la foto dei genitori, Michele la sua collezione di centinaia di macchinine, Fabrizio un cuscino a forma di cuore regalo di Adriana, anche lei disabile, che sposerà il 17 ottobre. «È un’altra cosa avere la propria vita, le proprie cose, senza nessuna imposizione», aggiunge Aniello. Vive su una sedia a rotelle, abita al piano terra della palazzina e con un ascensore interno raggiunge il piano intermedio dove risiedono gli altri amici e dove si fa pranzo comune. 24 ore su 24 si alternano dei volontari, e tra questi molti stranieri del movimento "Genti di pace".
Aniello ha conosciuto Sant’Egidio nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove, tra i palazzoni di via dell’Archeologia, in un ex locale lavatoio, ha sede il Laboratorio-Museo di arte sperimentale "Gli Amici", con opere che sono state esposte anche in mostre internazionali. «Per i disabili la pittura è una forma importante di comunicazione, raccontano ciò che pensano, anche sulle vicende che ascoltano in televisione», spiega Antonella. Mentre passeggiamo tra la tela di Annamaria dedicata ai bambini-soldato e quelle di Loredana, che disegna utilizzando tappi di bottiglia e altri materiali di recupero, nell’aria si diffondono alcune note rock, provenienti dalla piccola orchestra del laboratorio musicale, e un profumo di torta in cottura preparata per chiudere in festa, come di consuetudine, la giornata di incontro.
Dolci e non solo si possono gustare alla Trattoria degli Amici, il ristorante nel cuore di Trastevere dove il 50 per cento degli addetti che vi lavorano sono persone diversamente abili. I camerieri portano una t-shirt nera con la scritta Amico, e hanno l’aria professionale appresa al corso di formazione tenuto da un’impresa specializzata nel settore. Alle pareti, in vendita, i quadri realizzati nei laboratori di Tor Bella Monaca e negli altri laboratori della Comunità, per sostenere il progetto Dream.
«Marcello Mastroianni era un gran signore, quando tornava da Parigi mi chiedeva sempre "un vero caffè"»: ne ha serviti di clienti illustri, Edda. Trent’anni passati a via della Lungaretta in un bar-tabaccheria, «una delle prime rivendite di Trastevere», dice orgogliosa. Poi per lei, come per altre centinaia di anziani, il centro di Roma è diventato sempre più caro, l’affitto ha superato i 500 euro della pensione e ha dovuto cercare una nuova sistemazione. È stata fortunata, perché non ha dovuto fare conti con l’istituto o una periferia sconosciuta, e oggi può raccontare la sua storia seduta a prendere il caffè nella cucina di una casa accogliente, circondata dal giardino, a Monteverde, un quartiere che si arrampica sul colle del Gianicolo. Edda, infatti, vive in uno dei "Condomini aperti" realizzati da Sant’Egidio a Roma.
«Agli inizi degli anni ’70 gli anziani non erano certo di moda come oggi», raccontano Emanuela Valeriani e Giancarlo Penza, i due responsabili dell’area. La Comunità nascente fu però "costretta" a fare i conti con le terza età: «Furono proprio gli anziani del quartiere che cominciarono ad affacciarsi a Sant’Egidio». Anche in questo caso, è una storia che illumina il cuore del problema: «Filomena veniva a trovarci e cantava stornelli romani, era orgogliosa della sua chioma...». Poi la vicenda scivola su una china nota: i figli prendono la casa, mandano la donna in istituto, dove un colpo di forbici le taglia i capelli e spezza la sua vitalità. «Si lasciò morire. Capimmo che gli anziani sono talmente fragili che è facile manipolarne la volontà e sopprimerne la voglia di vivere. Scoprimmo che dovevamo lavorare su due fronti: abbattere la barriera della paura che isola i vecchi e li rende impenetrabili allo sguardo degli altri; e dare senso agli anni che passano».
Da questo e da altri incontri nascono le battaglie per evitare l’istituzionalizzazione e, in mancanza di altre strade, almeno la richiesta di istituti dignitosi; i diversi progetti per la cura e l’assistenza domiciliare, l’attenzione agli anziani dei quartieri dove la Comunità è presente e i progetti per alcune alternative concrete. Tra queste, appunto, i "Condomini aperti", cioè «un insieme di miniappartamenti in un palazzo dove vanno a vivere anziani con qualche difficoltà ma che sono ancora in grado di gestire autonomamente la propria vita», spiega Giancarlo. In ogni struttura ci sono degli spazi comuni e operatori della comunità, che intervengono al bisogno. Così Edda, con la signora Vincenzina, risiede in questo appartamento al piano terra di un condominio dove sono ospitati altri anziani autonomi, come Marisa e Giovanni, mentre all’ultimo piano c’è la "Casa alloggio". È questa la seconda proposta sperimentata da Sant’Egidio, rivolta ad anziani «estremamente fragili, la cui vita in alcuni casi è davvero appesa a un filo».
«Qui mi sento come neanche una regina», racconta Elsa, che con altri ospiti vive nel grande appartamento dell’ultimo piano in questa comunità protetta dove 24 ore su 24 si alternano i volontari, compresi medici e infermieri. Chiacchiera tanto, e indica un porcellino di creta con i soldi per l’adozione di Delfina, «una bambina africana che sostengono perché ha lo stesso nome di un’anziana che viveva qui e che Elsa aiutava a mangiare», racconta Olga, una delle volontarie. «Quando Delfina è morta hanno adottato questa bambina del Mozambico». L’anziana, classe ’22, sorride e continua a raccontare. L’infanzia e la Comunità sono i leit motiv di un discorso che non tocca gli anni del buio. Quelli trascorsi nel manicomio di Santa Maria della Pietà, quando mai avrebbe immaginato, un giorno, di essere di nuovo a casa, di avere un’amica da aiutare e una bambina africana da "adottare".
Vittoria Prisciandaro
Uomini e Religioni sulle strade della pace
 Muktar è una vittima dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia. Musulmano nel Paese con più musulmani al mondo, al momento del ciclone viveva a Banda Aceh, unica regione indonesiana in cui la sharia viene applicata alla lettera. Quel giorno ha perso tutto: due bambine, la moglie, l’abitazione. Ferito, venne ritrovato a due chilometri di distanza da casa e trasportato nell’ospedale di un’altra città. È qui che, dato per morto, con poca voglia di resistere, ha incontrato alcuni giovani di Sant’Egidio di Giacarta. Ristabilitosi e tornato nella sua città d’origine, ha potuto usufruire di un microcredito ricavato dalla raccolta organizzata da tutte le comunità di Sant’Egidio del mondo per le vittime dello Tsunami. Si è ricostruito una casa, l’orto, e ha ricominciato a vivere. Ora indossa una maglietta col simbolo della Comunità bene in vista: «Sono il primo musulmano di Sant’Egidio», ama ripetere. Al di là della battuta, vive davvero un legame profondo con i suoi amici cattolici. Muktar è una vittima dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia. Musulmano nel Paese con più musulmani al mondo, al momento del ciclone viveva a Banda Aceh, unica regione indonesiana in cui la sharia viene applicata alla lettera. Quel giorno ha perso tutto: due bambine, la moglie, l’abitazione. Ferito, venne ritrovato a due chilometri di distanza da casa e trasportato nell’ospedale di un’altra città. È qui che, dato per morto, con poca voglia di resistere, ha incontrato alcuni giovani di Sant’Egidio di Giacarta. Ristabilitosi e tornato nella sua città d’origine, ha potuto usufruire di un microcredito ricavato dalla raccolta organizzata da tutte le comunità di Sant’Egidio del mondo per le vittime dello Tsunami. Si è ricostruito una casa, l’orto, e ha ricominciato a vivere. Ora indossa una maglietta col simbolo della Comunità bene in vista: «Sono il primo musulmano di Sant’Egidio», ama ripetere. Al di là della battuta, vive davvero un legame profondo con i suoi amici cattolici.
Valeria Martano, responsabile della Comunità per l’Indonesia e l’Estremo Oriente, racconta questa storia e tante altre: c’è la vicenda del banchetto finale del Ramadan offerto ai musulmani poveri, o l’aiuto ai senzatetto delle città maggiori prestato congiuntamente da volontari di Sant’Egidio e medici delle associazioni musulmane. O ancora, «la presenza della Comunità nei campi profughi post-Tsunami, dove la divisione secondo le etnie e l’appartenenza religiosa era ferrea e, nonostante non fosse permesso ai cristiani di entrare, membri delle comunità indonesiane, godendo della fiducia delle autorità, sono andati portando il loro contributo», quando gli aiuti internazionali, anche italiani, erano fermi. «Il dialogo è la collaborazione nelle opere, l’amicizia quotidiana, l’incontro tra gente semplice i cui leader talvolta si odiano», dice Valeria. L’avventura del dialogo interreligioso della Comunità parte molti anni prima dello Tsunami e ha una prima, grande manifestazione nell’ottobre 1986 quando il Giovanni Paolo II decide di stupire il mondo convocando i leader planetari delle maggiori religioni ad Assisi.
Oltre alle varie commissioni pontificie, il Papa si avvale di almeno un decennio di fili intessuti pazientemente in giro per il mondo e per le strade di Roma da Sant’Egidio. Karol Wojtyla non sapeva, forse, che dalla cittadella francescana avrebbe dato vita a un itinerario lungo 22 anni, che la Comunità – con la sua emanazione "Uomini e Religioni" – porta avanti annualmente con tappe tra città europee e non, e che quest’anno, dal 6 all’8 settembre, approda a Cracovia. La "Preghiera della Pace" – il nome è rimasto quello wojtiliano – è una "tre giorni" di panels su argomenti di attualità, in cui intervengono leader di tutte le fedi e alcuni dei maggiori protagonisti sulla scena mondiale, che si conclude con l’invocazione a Dio, secondo le diverse tradizioni, e l’abbraccio di pace. Ma è solo l’espressione epifanica di un lavorio continuo e sotterraneo, instancabile, divenuto una delle principali attività santegidine, che costituisce una delle dimensioni nuove del dialogo del nostro tempo, e che ha permesso una serie di contatti di diplomazia dal basso, che hanno portato frutti di pace. Un dialogo che in questi anni si è allargato anche alla cultura laica, per provare a dare un’anima alla globalizzazione, in chiave solidale.
l.a.
Pena di morte, incubo da cui uscire
«La storia», scriveva James Joice nell’Ulisse, «è un incubo da cui sto cercando di svegliarmi». Josè Joaquin Martinez quando chiude gli occhi ripiomba ancora nell’incubo. Ecuadoregno cresciuto negli Stati Uniti, ha trascorso più di tre dei suoi 38 anni nel braccio della morte a Tampa, in Florida. Innocente condannato alla pena capitale, ha fatto fatica a non impazzire: «La mia vicenda ha dell’incredibile. Mia moglie, sentendosi tradita, ha architettato un piano per accusarmi di omicidio e io, a 29 anni, con due bambine, mi sono ritrovato in carcere. In più, sono ispanico. E sa quanti come me sono usciti vivi dai bracci della morte americani? Semplice: nessuno!», dice, raccontando la sua storia. «Se non fosse stato per i miei genitori e gli amici europei, forse mi sarei disperato e non sarei mai riuscito a dimostrare la mia innocenza. E dire che, prima di entrare nel carcere di Tampa, ero assolutamente favorevole alla pena di morte».
Ultimamente, per fortuna, le cose sono cambiate: oggi sono 131 gli innocenti liberati dai bracci della morte Usa, uno dei Paesi che vanta un sofisticato sistema giudiziario, pieno di falle. «Quando ormai ero senza speranza, si è materializzata Sant’Egidio. Saputa la mia storia, le comunità di Madrid e Barcellona hanno cominciato a scrivermi, hanno contattato i miei parenti e hanno lottato perché il mio caso fosse riaperto, fino a vincere. Sono rinato».
Dominique Green, invece, non ce l’ha fatta. Afroamericano, arrestato a 18 anni per un crimine commesso da altri che erano con lui, è stato accusato dai compagni per avere uno sconto di pena. È dall’incontro con lui, in Texas, che è iniziata la campagna mondiale della Comunità di Sant’Egidio per una moratoria universale, fino alla completa eliminazione della pena capitale sul pianeta. Il movimento delle "Città per la vita", le "Città contro la pena di morte", in 6 anni ha raccolto mille adesioni in tutto il mondo e ha inventato un nuovo modo di coinvolgere le opinioni pubbliche anche nei Paesi che mantengono la pena capitale. La creazione di un fronte laico e interreligioso mondiale, con più di 5 milioni di firme raccolte sotto all’Appello per una moratoria universale e consegnate al presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 novembre 2007, si è rivelato decisivo per sconfiggere l’argomento che aveva bloccato per 14 anni l’approvazione della prima risoluzione contro la pena di morte da parte dell’Onu: erano la prova che un mondo senza pena di morte non è una invenzione "neo-colonialista" dei diritti umani del Nord del mondo o dell’Europa, ma la richiesta di un nuovo standard di rispetto dei diritti umani e della vita.
«La pena di morte degrada lo Stato ponendolo al livello di chi uccide e congela nell’odio anche le famiglie delle vittime», dice don Marco Gnavi, della Comunità di Roma. «La difesa della vita deve essere senza eccezioni, dal suo inizio alla sua fine naturale, anche nel caso di un eventuale colpevole». Sant’Egidio lavora attivamente con numerosi Paesi: da questo impegno solo negli ultimi due anni è scaturita l’abolizione della pena capitale in Uzbekistan, nel Kazakhstan, in Togo, in Gabon. Con le sue campagne, la Comunità ha anche voluto aiutare il superamento della divisione tra favorevoli alla "moratoria" e sostenitori dell’"abolizione" e ha dato un contributo alla nascita, avvenuta a Sant’Egidio nel 2002, della Coalizione mondiale contro la pena di morte.
l.a.
Dream, il sogno di un Terzo mondo senza Aids
Nelson Mandela diceva che dalla vita esce vittorioso il sognatore che non si è mai arreso. Dream (Drug Resource Enhancement against Aids and Malnutrition) è un vasto programma di lotta all’Aids nell’Africa sub-sahariana, uno dei sogni – realizzati – di Sant’Egidio. I Paesi interessati dal progetto sono 10, 75 mila i malati in cura, più di 2 mila le persone formate localmente tra medici, infermieri, assistenti domiciliari, tecnici di laboratorio. Tra questi, tante le donne, come Anna Maria Muhai, che porta nella borsa la fotografia di quando pesava meno di 30 chili ed era coperta di piaghe, e ora è una bella donna, tra i pilastri di Mulheres para o Dream.
 In un centro Dream si respira un’aria serena, sui muri campeggia la scritta «Qui non si paga» e, mentre i bambini giocano, le donne fanno il test. Per coloro che, anche al secondo controllo, risultano positive inizia immediatamente il counseling, poi la prima istruzione quindi la consegna della terapia e il sostegno nutrizionale. C’è la presa in carico della donna in gravidanza, che verrà monitorata dalla rete di laboratori di biologia molecolare. Grazie a questo iter il 98 per cento dei bambini nasce sano anche da madri malate, più del 90 per cento degli adulti con Aids riprende a vivere, il 95 per cento è fedele a una terapia che, secondo alcuni esperti internazionali, sarebbe impossibile: troppo costosa e troppo complicata. Incluse le famiglie, oggi un milione di persone in Africa vive meglio grazie a Dream, che è una delle due best practices studiate ai summit dei capi di Stato africani. Nel 2005 l’Oms ha dichiarato Dream un modello di intervento per i Paesi a risorse limitate, poi sono arrivati vari altri riconoscimenti scientifici. In un centro Dream si respira un’aria serena, sui muri campeggia la scritta «Qui non si paga» e, mentre i bambini giocano, le donne fanno il test. Per coloro che, anche al secondo controllo, risultano positive inizia immediatamente il counseling, poi la prima istruzione quindi la consegna della terapia e il sostegno nutrizionale. C’è la presa in carico della donna in gravidanza, che verrà monitorata dalla rete di laboratori di biologia molecolare. Grazie a questo iter il 98 per cento dei bambini nasce sano anche da madri malate, più del 90 per cento degli adulti con Aids riprende a vivere, il 95 per cento è fedele a una terapia che, secondo alcuni esperti internazionali, sarebbe impossibile: troppo costosa e troppo complicata. Incluse le famiglie, oggi un milione di persone in Africa vive meglio grazie a Dream, che è una delle due best practices studiate ai summit dei capi di Stato africani. Nel 2005 l’Oms ha dichiarato Dream un modello di intervento per i Paesi a risorse limitate, poi sono arrivati vari altri riconoscimenti scientifici.
Cristina Moscatelli, specialista dell’Emergenza presso la Centrale operativa del 118 a Grosseto, e per vari mesi all’anno medico volontario in Africa per Dream, ha cominciato a occuparsi del programma nel 2004: «Dream è uno dei pochi programmi che si occupa di malnutrizione. La risposta alla terapia», spiega, «è infatti determinata da un’alimentazione adeguata: se un bambino in trattamento è denutrito, l’efficacia risulta drasticamente ridotta». Quando un paziente comincia a rispondere alla cura e sta meglio, gli si propone di lavorare per Dream. Quasi tutti, in gran parte donne, accettano e cominciano a prendersi cura di altri pazienti con visite domiciliari quotidiane che puntano ad assicurarsi che la terapia venga seguita correttamente. L’impatto di malati che migliorano sugli altri che avevano perso la speranza è dirompente. All’inizio, al programma lavorava un’equipe europea. «Per implementare il progetto, che ha ormai sette anni, partivano, a ondate mensili, 15 o 16 medici di Sant’Egidio dall’Europa», spiega Gianni Guidotti, uno dei medici coordinatori di Dream. «Ora partono al massimo uno o due coordinatori ogni tre, quattro mesi. Il personale è al 99 per cento locale». Per Sant’Egidio «Dream è stata una scelta obbligata: non potevamo accettare un genocidio, mentre il mondo occidentale restava a guardare».
l.a.
L’Onu di Trastevere sui sentieri della pace
«Nella nostra personalità c’erano aspetti plasmati da anni di clandestinità. Foresta e fucile. La relazione con Sant’Egidio, per questo, per noi fu speciale. Favorì una visione della vita diversa rispetto al passato. Incontrare gente con cui ragionare in modo diverso, senza per forza contrapporsi, ci ha aiutato moltissimo, fino a farci rientrare in un processo legale e politico». A parlare è Pablo Monsanto, leader della guerriglia guatemalteca e negoziatore ufficiale nelle trattative con il governo, svoltesi in gran parte nei locali di Sant’Egidio, e sfociate nell’accordo di pace del 1996. «Sentimmo subito», continua l’ex guerrigliero, «che Sant’Egidio era più umana della altre organizzazioni. Con l’Onu avevamo una relazione istituzionale, a volte anche con la Commissione di riconciliazione nazionale. Con loro, invece, s’era instaurato un rapporto intimo, spirituale. L’amicizia con Roberto, Matteo, con Riccardo: li abbiamo sentiti parte della nostra famiglia, anche dopo la firma della pace, anche ora».
È la testimonianza di una faticosa conversione alle ragioni della pace di un uomo abituato a dialogare con il mitra, un percorso di riscatto dai risvolti diplomatici, che vede nel rapporto umano la chiave del successo. Sono parole che colpiscono e interrogano: come si è giunti a trattare con fazioni armate o a fare i conti con governi di Paesi dilaniati dai conflitti? La domanda, in forma più rude, fu posta ad Andrea Riccardi anche da un giornalista americano, all’indomani della storica sigla degli accordi di pace in Mozambico nel ’92: «Quand’è che avete deciso di lasciare le attività di sostegno personale ai poveri per la diplomazia?». La risposta di Riccardi fu diretta e laconica: «Mai».
«Perché il lavoro per la pace», dice Leone Gianturco, che ha seguito direttamente le trattative per il Mozambico, «è la naturale prosecuzione del servizio ai poveri che ogni membro della Comunità fa. La saggezza di portare due fazioni mozambicane contrapposte attorno a un tavolo e far loro firmare la pace è la stessa che mostra uno qualsiasi di noi che vuole bene a un povero e cerca di portargli amicizia».
Osservata dall’esterno, con alcuni dei suoi membri immortalati accanto ai rappresentanti politici più importanti della storia recente, o nelle sedi diplomatiche più calde del mondo, sembra normale considerare la Comunità come un’associazione di peacemaking o una Ong. Basti pensare alle trattative per la riunificazione della Costa d’Avorio, dove la Comunità si è impegnata in sinergia con il Burkina Faso, o alla fine della guerra etnica e civile in Burundi, che porta anche la firma di Sant’Egidio, in stretta collaborazione con alcuni Grandi africani, primi tra tutti Nyerere e Mandela.
Il punto è che «Sant’Egidio non è tecnica diplomatica e basta», dice Mario Giro, responsabile dell’Ufficio internazionale della Comunità. «L’assenza di interessi economici, la credibilità, il tratto umano, la capacità di cogliere i diversi livelli dello scontro e l’intreccio dei fattori sociali, etnici, religiosi, culturali, la capacità di trovare e costruire un linguaggio comune, la cura di "umanizzazione": in questo modo gli stessi negoziati diventano per chi ha usato fino ad allora i soli strumenti dello scontro e delle armi, le chiavi di un successo che ha radici evangeliche». Fino a diventare, secondo la definizione di Igor Man, l’«Onu di Trastevere».
l.a.
Impagliazzo: se i poveri cambiano il mondo
 Marco Impagliazzo, 47 anni, storico, è il presidente di Sant’Egidio. Gli chiediamo se la Comunità, nata a Roma, abbia una sua missione "italiana". «Dovunque c’è una comunità, c’è gente che prega, che cerca di creare una famiglia con i poveri, e che sente una responsabilità personale perché non ci si accontenti solo della propria vita e della nostra società com’è. Questo è vero in Italia come in ogni parte del mondo dove siamo presenti. È stato sempre decisivo il rapporto con la città, i suoi dolori, le sue povertà, sofferenze, le sue speranze, la sua gente. Lavorare per il bene della città in Italia significa cose diverse. Sostegno agli anziani in difficoltà o soli, accoglienza agli immigrati, impegno perché i bambini non crescano alla scuola della violenza o del disinteresse, vicinanza ai poveri che vivono per strada. Nelle nostre "scuole della pace" in quartieri come Scampia, a Napoli, o in certi quartieri di Messina o di Palermo, c’è una pedagogia non violenta che da tanti anni offre modelli alternativi e meno disperati ai ragazzi. Poi c’è l’impegno delle comunità nel Nord Italia, come a Milano, Genova, Novara e altrove, che cercano ogni giorno i modi per stemperare linguaggio e comportamenti incivili verso gli immigrati. Penso alla preghiera serale aperta a tutti ovunque c’è una comunità, dove ci si incontra con la Parola di Dio e si vive il tempo e lo spazio della gratuità in un mondo troppo materialista». Marco Impagliazzo, 47 anni, storico, è il presidente di Sant’Egidio. Gli chiediamo se la Comunità, nata a Roma, abbia una sua missione "italiana". «Dovunque c’è una comunità, c’è gente che prega, che cerca di creare una famiglia con i poveri, e che sente una responsabilità personale perché non ci si accontenti solo della propria vita e della nostra società com’è. Questo è vero in Italia come in ogni parte del mondo dove siamo presenti. È stato sempre decisivo il rapporto con la città, i suoi dolori, le sue povertà, sofferenze, le sue speranze, la sua gente. Lavorare per il bene della città in Italia significa cose diverse. Sostegno agli anziani in difficoltà o soli, accoglienza agli immigrati, impegno perché i bambini non crescano alla scuola della violenza o del disinteresse, vicinanza ai poveri che vivono per strada. Nelle nostre "scuole della pace" in quartieri come Scampia, a Napoli, o in certi quartieri di Messina o di Palermo, c’è una pedagogia non violenta che da tanti anni offre modelli alternativi e meno disperati ai ragazzi. Poi c’è l’impegno delle comunità nel Nord Italia, come a Milano, Genova, Novara e altrove, che cercano ogni giorno i modi per stemperare linguaggio e comportamenti incivili verso gli immigrati. Penso alla preghiera serale aperta a tutti ovunque c’è una comunità, dove ci si incontra con la Parola di Dio e si vive il tempo e lo spazio della gratuità in un mondo troppo materialista».
• Come si colloca Sant’Egidio nella Chiesa italiana?
«Come una realtà di credenti, che sente un Paese in difficoltà. In Italia sembra perdersi il senso di una comune appartenenza nazionale, mentre ci si ripiega sul particolare e sul locale. L’Italia ha senso come comunità nazionale, con un suo profilo nel mondo. In Africa vent’anni fa il nostro Paese aveva un ruolo utile. Bisogna rilanciare l’Italia nel mondo: sulle frontiere africane e su quelle della costruzione europea. Senza l’Europa unita le nostre piccole patrie europee sono destinate a finire».
• Quali sono le priorità, oggi, per Sant'Egidio?
«La grande crisi mondiale rappresenta una grande chance, anche per i cristiani. Mentre è forte la tentazione e il peso dell’irrilevanza, perché ognuno sente di essere troppo piccolo e non contare niente di fronte ai processi mondiali, o di fronte alla stessa politica nazionale, penso sia importante tornare a un approfondimento delle proprie radici: non quelle del dialetto, ma la Bibbia, la carità, la responsabilità che ognuno aspiri davvero alla santità. Che a livello di comportamenti vuole dire anche restare umani in tempi che a volte sono disumani. I progetti vengono dopo. Nella chiesa di Sant’Egidio c’è un crocifisso di legno rimasto senza braccia, solo il tronco. Lo chiamiamo il Cristo dell’impotenza. La sfida è cercare di essere quelle braccia, cambiare il mondo con mezzi deboli, non con il potere. Avere una visione ampia in un tempo povero di visioni».
Michele Brancale
Estroversi per vocazione sognando l'Eurafrica
Dall’Europa all’Africa, dall’Asia all’America latina, Sant’Egidio è ormai una realtà radicata saldamente in ogni angolo del mondo. E ovunque sia presente la Comunità, piano piano si fa strada il modello del "dialogo vissuto".
Giovanni Paolo II, in un incontro nel novembre 1986, definì Sant’Egidio una comunità che ovunque «sarà sempre romana». Il movimento, romano di nascita e ben calato nella realtà locale, usciva sempre più decisamente dai confini capitolini, andava oltre l’Italia e l’Europa. E il Papa, oltre ad apprezzare il radicamento nella sua diocesi, percepì una vocazione «romana» all’universalità.
Oggi Sant’Egidio è globale. Difficile comprenderla vedendola da Roma solamente. Ha mille voci, un volto decisamente più scuro di quello europeo, parla le lingue dell’Est, quelle asiatiche, i dialetti del continente nero. Per capire, e provare a tracciare un profilo degli uomini e delle donne di Sant’Egidio, è necessario quindi compiere un viaggio virtuale in più continenti.
 L’itinerario comincia da Anversa, nel cuore dell’Europa, a due passi da Bruxelles. A raccontare la propria esperienza è Hilde Kieboom, 44 anni, libera professionista, sposata, una figlia, che è responsabile delle comunità belghe e olandesi, un migliaio di persone. «Finita l’epoca coloniale», dice, «l’Africa è scomparsa completamente dal nostro orizzonte e con essa si è affievolito anche quell’afflato verso l’altro, il povero. Oggi siamo finiti a essere talmente insignificanti che, per crearci un’identità, ci dividiamo. C’è il rischio reale, infatti, che il nostro – uno dei Paesi più piccoli d’Europa – si divida in due staterelli, la Franconia e la Vallonia. Una volta il Belgio offriva un numero altissimo di missionari al Terzo mondo, ora siamo qui a tracciare linee di demarcazione. Con la Comunità, che qui è arrivata agli inizi degli anni ’80, abbiamo riscoperto un aspetto di estroversione che sembrava ormai sepolto. La nostra mensa che dà da mangiare a 600 poveri, è dedicata a Damiano De Veuster, un prete belga finito alle Hawaii nell’800 a predicare il Vangelo ai lebbrosi, che sarà canonizzato il prossimo 11 ottobre. Lì ha conquistato migliaia di cuori con la sua semplicità e simpatia. Ecco, è questo il modello di uomo belga che ci piace». L’itinerario comincia da Anversa, nel cuore dell’Europa, a due passi da Bruxelles. A raccontare la propria esperienza è Hilde Kieboom, 44 anni, libera professionista, sposata, una figlia, che è responsabile delle comunità belghe e olandesi, un migliaio di persone. «Finita l’epoca coloniale», dice, «l’Africa è scomparsa completamente dal nostro orizzonte e con essa si è affievolito anche quell’afflato verso l’altro, il povero. Oggi siamo finiti a essere talmente insignificanti che, per crearci un’identità, ci dividiamo. C’è il rischio reale, infatti, che il nostro – uno dei Paesi più piccoli d’Europa – si divida in due staterelli, la Franconia e la Vallonia. Una volta il Belgio offriva un numero altissimo di missionari al Terzo mondo, ora siamo qui a tracciare linee di demarcazione. Con la Comunità, che qui è arrivata agli inizi degli anni ’80, abbiamo riscoperto un aspetto di estroversione che sembrava ormai sepolto. La nostra mensa che dà da mangiare a 600 poveri, è dedicata a Damiano De Veuster, un prete belga finito alle Hawaii nell’800 a predicare il Vangelo ai lebbrosi, che sarà canonizzato il prossimo 11 ottobre. Lì ha conquistato migliaia di cuori con la sua semplicità e simpatia. Ecco, è questo il modello di uomo belga che ci piace».
Particolare attenzione Sant’Egidio mostra nei confronti dell’Africa. Negli ultimi 15 anni la Comunità si è notevolmente radicata nel continente. E il forte senso di legame tra Nord ricco e Sud ha portato al conio di un neologismo: «Sognamo l’"Eurafrica" e proviamo a realizzarla sentendo indissolubile il legame tra noi e i fratelli europei», dice Kpakilè Felemou, biologo, 43 anni e quattro figli, responsabile delle comunità di Sant’Egidio della Guinea Conakry. «L’Africa sembra un continente alla deriva, la Comunità ha voluto rimetterlo al centro con attività di pace e trasmissione della propria esperienza», continua Felemou. «Così c’è stata una vera esplosione di Sant’Egidio. Anche per questo Andrea Riccardi dice che "Sant’Egidio è africana". Solo da noi, in un Paese di nove milioni di abitanti, siamo 1.200».
La Guinea Conakry è poverissima, 60 per cento di analfabetismo, 40 per cento di disoccupazione. Un Paese, insomma, da cui chi può fugge. «È vero, ma da quando viviamo l’esperienza della Comunità, qui come in tanti altri Stati africani, è maturato in noi un senso di responsabilità verso la nostra terra. Siamo cristiani laici e ci sentiamo chiamati a giocare un ruolo nella società. Con il servizio gratuito ai poveri e ai prigionieri, abbiamo scoperto che possiamo cambiare i nostri Paesi; allo stesso tempo, sentiamo un forte debito civico verso la nostra gente. Per questo chi può studia; altri lavorano. Ma tutti hanno il forte desiderio di rimanere in patria e cambiare le cose».
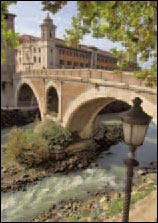 C’è anche un altro aspetto, aggiunge Felemou: «Molti di noi sono venuti a Roma, in visita alla Comunità, o in Europa. Qui abbiamo scoperto l’abbaglio di una società perfetta che non esiste. Al contrario ci sono stenti, esclusione, spesso anche razzismo. È molto saggio ciò che dice Sant’Egidio, secondo me: da una parte sostiene l’idea di una società multiculturale, dall’altra chiede ai ricchi del mondo di non scordarsi del Sud, infine dà motivi a quelli come noi per rimanere ed essere protagonisti di una resurrezione dell’Africa». C’è anche un altro aspetto, aggiunge Felemou: «Molti di noi sono venuti a Roma, in visita alla Comunità, o in Europa. Qui abbiamo scoperto l’abbaglio di una società perfetta che non esiste. Al contrario ci sono stenti, esclusione, spesso anche razzismo. È molto saggio ciò che dice Sant’Egidio, secondo me: da una parte sostiene l’idea di una società multiculturale, dall’altra chiede ai ricchi del mondo di non scordarsi del Sud, infine dà motivi a quelli come noi per rimanere ed essere protagonisti di una resurrezione dell’Africa».
L’idea di cambiare la società dall’interno è un motivo ricorrente nei discorsi dei responsabili internazionali di Sant’Egidio. Ne parliamo con un altro interlocutore che vive in un Paese dove conflitti e violenza hanno contrassegnato la società per anni: il Salvador. Jaime Aguilar è un programmatore di 43 anni che vive nella capitale del piccolo Stato centramericano: «Sant’Egidio è nata all’indomani delle tragica morte di monsignor Oscar Romero», spiega. «Il suo segretario, monsignor Delgado, a metà degli anni ’80, iniziò a parlare di Sant’Egidio e io rimasi molto affascinato. All’epoca si diceva che per cambiare le cose bisognava rivoluzionare le strutture. Arriva Sant’Egidio e ci dice: voi potete cambiare le strutture ma iniziate dal vostro cuore e dalla vita dei più poveri».
Obiettivo non facile, in una società così divisa. «Sì, e dopo la fine della guerra fredda, la situazione peggiorò, con l’offensiva della guerriglia fin dentro le strade della mia città. Noi facevamo l’Escuelita ai bambini delle famiglie che per la guerra scappavano dai villaggi e vivevano in baracche poverissime. Ora la guerra non c’è più, ma la violenza resta spaventosa: in un Paese di appena 5 milioni e mezzo di abitanti ci sono in circolazione ancora molte armi e nell’ultimo anno si è registrata una media di dodici omicidi al giorno. Si spendono 600 milioni di dollari, il 6 per cento del Pil, nella sicurezza privata, che conta un esercito parallelo di 25 mila uomini, cui bisogna aggiungere i 17 mila della Polizia nazionale. E poi c’è il fenomeno delle maras, le bande giovanili nate negli Stati Uniti negli anni ’90 tra i nostri emigrati. Molti dei loro membri sono stati rimpatriati e qui hanno trovato un terreno incredibilmente fertile. Si calcola che almeno 100 mila persone vi appartengano. Le maras impongono la loro autorità su interi quartieri dei centri urbani, hanno codici interni e riti di iniziazione. Chi abbandona la banda viene punito con la morte. E lo Stato risponde solo con la repressione. Noi abbiamo scelto di fare scuola anche nei quartieri delle maras».
Aguilar è appena divenuto padre di una terza figlia, ha una famiglia e una comunità. Mi chiedo se, con il suo impegno, non stia rischiando troppo. «C’è da dire», risponde, «che ci muoviamo sempre con cautela e che ormai in molte zone controllate dalle maras abbiamo conquistato la fiducia della gente, occupandoci dei loro figli. Poi, è vero che ho tre figlie, ma che futuro posso sognare per loro in un Paese che uccide dodici persone al giorno? È proprio per i nostri figli che andiamo a fare scuola a quei bambini. Ci incoraggia molto il fatto che nei quartieri dove facciamo l’Escuelita da anni, le maras non sono mai arrivate: annunciamo il Vangelo in situazioni di miseria, ma proponiamo anche una scelta di campo per ragazzi e genitori».
 La Comunità è anche uno stile di vita, un modo di affrontare i ritmi spesso frenetici, dando la preminenza alla dimensione spirituale e all’incontro umano. Lo spiega bene Erlip Vitarsa, venticinquenne di Jakarta, responsabile delle comunità indonesiane: «Se da voi il mondo va a 100 all’ora, qui va almeno al doppio. Le società asiatiche sono veloci, si lavora con orari impossibili e il rischio è perdere l’anima. Anche per questo diamo molta importanza alla preghiera serale, cui partecipano i membri della nostra comunità così come tanti amici, per testimoniare la presenza di Dio e parlare con lui, per riflettere, calmi, almeno un po’ al giorno. Questo nostro atteggiamento, assieme all’amore che da sempre dimostriamo per i bambini poveri, in grande maggioranza di fede islamica, ha conquistato i cuori di molti musulmani». È questo il dialogo vissuto, dice Vitarsa. «Il dialogo è una vera necessità: per esempio nelle nostre comunità molti sono di origine cinese. E in un periodo in cui si respirava aria di forte intolleranza contro l’etnia cinese e contro i cristiani, sono stati i bambini musulmani che conosciamo e serviamo da anni ad aiutarci, difendendoci anche davanti agli adulti che propugnavano violenza». La Comunità è anche uno stile di vita, un modo di affrontare i ritmi spesso frenetici, dando la preminenza alla dimensione spirituale e all’incontro umano. Lo spiega bene Erlip Vitarsa, venticinquenne di Jakarta, responsabile delle comunità indonesiane: «Se da voi il mondo va a 100 all’ora, qui va almeno al doppio. Le società asiatiche sono veloci, si lavora con orari impossibili e il rischio è perdere l’anima. Anche per questo diamo molta importanza alla preghiera serale, cui partecipano i membri della nostra comunità così come tanti amici, per testimoniare la presenza di Dio e parlare con lui, per riflettere, calmi, almeno un po’ al giorno. Questo nostro atteggiamento, assieme all’amore che da sempre dimostriamo per i bambini poveri, in grande maggioranza di fede islamica, ha conquistato i cuori di molti musulmani». È questo il dialogo vissuto, dice Vitarsa. «Il dialogo è una vera necessità: per esempio nelle nostre comunità molti sono di origine cinese. E in un periodo in cui si respirava aria di forte intolleranza contro l’etnia cinese e contro i cristiani, sono stati i bambini musulmani che conosciamo e serviamo da anni ad aiutarci, difendendoci anche davanti agli adulti che propugnavano violenza».
Comunità completamente autoctone, gruppi di amici, uomini e donne che non hanno rinunciato al sogno di cambiare il mondo, Vangelo alla mano, a partire dal proprio cuore. «La comunità è la compagna della mia vita», conclude Jaime, dal cuore dell’America. «Mi ha detto che se ascolto il Vangelo nel mio cuore c’è una forza da sprigionare. Io, semplicemente, ci ho creduto».
Luca Attanasio
Marazziti: l’Italia vittima della paura
 Mario Marazziti è il portavoce storico di Sant’Egidio. Il suo compito, dice, è «comunicare quello che è la Comunità», dare forza a «quelli che non hanno voce, dai barboni dell’emergenza freddo ai bambini invisibili da registrare all’anagrafe con il programma "Bravo"». O, ancora, intervenire per «cercare di aiutare a non imbarbarire una società impaurita senza motivo». Mario Marazziti è il portavoce storico di Sant’Egidio. Il suo compito, dice, è «comunicare quello che è la Comunità», dare forza a «quelli che non hanno voce, dai barboni dell’emergenza freddo ai bambini invisibili da registrare all’anagrafe con il programma "Bravo"». O, ancora, intervenire per «cercare di aiutare a non imbarbarire una società impaurita senza motivo».
• Perché la paura percepita dagli italiani è immotivata?
«Saranno due anni che siamo assaliti dalle notizie di microviolenza, tanto che tutti sono convinti che siamo sempre a rischio di stupro o di rapina. Eppure in Italia ci sono il 300 per cento in meno di furti in appartamento che in Gran Bretagna, e ci sono città, da Parigi a Los Angeles a Città del Capo dove le aggressioni e gli omicidi sembrano un’epidemia, a confronto con Roma e Milano. È un lavoro in salita aiutare a non individuare capri espiatori negli immigrati e nei poveri. In questo Sant’Egidio è anche un antidoto spirituale al pessimismo e un filtro culturale e umano alla banalità e al conformismo semplificatorio, che porta a individuare nemici dappertutto, mentre spesso il problema è dentro di noi, nell’aria che respiriamo e creiamo».
• Può spiegare meglio?
«Il clima civile in Italia e in Europa si è deteriorato. Sono molti i deputati europei eletti recentemente che fanno riferimento a programmi "localisti", con sfumature di intolleranza e razzismo. Da noi si è arrivato all’assurdo che il "decreto sicurezza" ha rischiato di mettere fuori legge le famiglie italiane che solo grazie all’aiuto di badanti e colf "irregolari" possono andare a lavorare e garantire una vita dignitosa ai propri figli e anziani. Quando si è deciso di rimediare è arrivata una nuova tassa di 500 euro per famiglia; il governo per poter regolarizzare ha fissato un tetto di reddito che è quasi doppio di quello che dichiarano gran parte degli italiani. Non sono in tanti a dirlo».
• Invece Sant’Egidio interviene e fa spesso notizia...
«A volte. E solo perché i problemi sono tanti e le voci sono poche. Non ci interessa mai la denuncia in quanto tale, e non siamo resi miopi dall’ideologia. La verità è che gran parte delle cose importanti in cui siamo coinvolti, o anche grandi temi ecclesiali, sono ignorati: l’Africa non esiste, per i media; non esistono milioni di anziani e un messaggio culturale vitalista indirettamente dice: quando sei anziano sei già morto. Si fa strada una mentalità istintivamente pro-eutanasia. Di recente una conferenza internazionale con la Chiesa copta di Etiopia, con il patriarca Paulos, un uomo che è stato in carcere anni durante il regime di Menghistu, è come non fosse accaduta per l’opinione pubblica. La testimonianza dei martiri contemporanei non esiste».
• La Comunità ha più di 40 anni, tanti faticano a pensare al futuro…
«Il "no future" è diventato vulgata. Penso che bisogna ricominciare a parlare e ad assumersi qualche responsabilità: insegnanti, genitori, educatori. O il futuro diventa davvero difficile. La nostra esperienza è che quando ci si mette a ragionare e parlare, anche dove scoppia la rabbia popolare, le cose, poi, cambiano».
m.b.
Testimoni della speranza in dialogo con il mondo
Leader politici internazionali, uomini di Chiesa, intellettuali laici e credenti di ogni fede: la storia di Sant’Egidio è costellata di incontri e di amicizie, anche importanti, che si sono stabilite nel tempo. E che spiegano in maniera emblematica la capacità di incontro della Comunità.
Sant’Egidio ha sempre avuto dimestichezza con la figura del "testimone", colui che ha scelto o è stato costretto a parlare delle proprie convinzioni e della propria fede più con la vita che con le parole. Dal 1993, la Comunità ha in affidamento la basilica di San Bartolomeo sull’isola Tiberina. Ed è qui che, dal 1999, in preparazione al Grande Giubileo dell’anno 2000, si riunì la commissione "Nuovi Martiri" voluta da Giovanni Paolo II per indagare sui testimoni della fede cristiana morti durante il Ventesimo secolo. Per due anni, la commissione si riunì nei locali della chiesa, raccogliendo circa 12 mila dossier di martiri e testimoni della fede giunti dalle diocesi di tutto il mondo. Tra i frutti di quel lavoro ci fu la preghiera ecumenica al Colosseo che, durante il Giubileo, mise l’uno accanto agli altri Papa Wojtyla e i rappresentanti di tutte le principali Chiese cristiane, riunite intorno a figure universali come Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein e monsignor Oscar Romero.
 All’indomani del Giubileo, Giovanni Paolo II volle dare una forma stabile a quella ricerca sulla memoria dei testimoni della fede del Novecento. Ed è stato così che, nell’ottobre del 2002, con una solenne celebrazione ecumenica alla presenza dei cardinali Camillo Ruini, Walter Kasper e Francis George, e del patriarca ortodosso rumeno Teoctist, venne posta sull’altare maggiore della basilica di San Bartolomeo una grande icona dedicata ai martiri del Novecento. L’icona rappresenta, con una simbologia presa dall’Apocalisse, le vicende dei martirii di cui si è venuti a conoscenza attraverso i lavori della commissione; memorie di martiri sono collocate nelle cappelline laterali della chiesa, ognuna dedicata a una situazione storica particolare, dai cristiani morti nelle guerre civili in Spagna e Messico, ai testimoni uccisi sotto il regime nazista o durante il comunismo. All’indomani del Giubileo, Giovanni Paolo II volle dare una forma stabile a quella ricerca sulla memoria dei testimoni della fede del Novecento. Ed è stato così che, nell’ottobre del 2002, con una solenne celebrazione ecumenica alla presenza dei cardinali Camillo Ruini, Walter Kasper e Francis George, e del patriarca ortodosso rumeno Teoctist, venne posta sull’altare maggiore della basilica di San Bartolomeo una grande icona dedicata ai martiri del Novecento. L’icona rappresenta, con una simbologia presa dall’Apocalisse, le vicende dei martirii di cui si è venuti a conoscenza attraverso i lavori della commissione; memorie di martiri sono collocate nelle cappelline laterali della chiesa, ognuna dedicata a una situazione storica particolare, dai cristiani morti nelle guerre civili in Spagna e Messico, ai testimoni uccisi sotto il regime nazista o durante il comunismo.
Oggi, camminare tra le navate della basilica di San Bartolomeo significa compiere, come ha detto papa Benedetto XVI in occasione della sua visita alla chiesa del 7 aprile 2008, «un pellegrinaggio alla memoria dei martiri del Ventesimo secolo, innumerevoli uomini e donne che hanno versato il loro sangue per il Signore. Ma Gesù Risorto illumina la loro testimonianza e comprendiamo così il senso del martirio. È la forza dell’amore, inerme e vittorioso anche nell’apparente sconfitta».
Sant’Egidio, quindi, conosce bene chi siano i martiri e il valore del loro sacrificio. Ma la Comunità non accoglie solo testimoni che sono morti perché la loro vita parlasse della loro fede e delle loro convinzioni. Nel corso dei decenni, sui palchi degli Incontri internazionali di preghiera per la pace, a cominciare dal primo, storico appuntamento voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, si sono alternati centinaia di testimoni con le più diverse esperienze e dalle più diverse provenienze: leader mondiali, politici, attivisti, economisti, intellettuali, esponenti di ogni fede e confessione. Tutti hanno preso qualcosa dalla Comunità, e tutti hanno lasciato qualche cosa. Tutti si sono interrogati sul significato della parola «testimonianza». Negli ultimi anni, ad esempio, è stato lo scrittore Roberto Saviano, autore di Gomorra, a incrociare il suo cammino con quello di Sant’Egidio, in tandem con l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, che ha ospitato nella sua città l’Incontro per la pace del 2007, a cui ha partecipato anche papa Benedetto XVI.
 Parlando appena qualche mese fa proprio nella basilica di San Bartolomeo, con alle spalle la grande icona dei Martiri del Ventesimo secolo, Saviano, che per il suo libro è stato minacciato dalla camorra e oggi vive sotto scorta, ha provato a spiegare cosa significhi il martirio nel nostro tempo, cosa comporti rendere testimonianza anche quando la propria vita è minacciata. Per lo scrittore, «il vero martirio, oggi, è la diffamazione, la distruzione della dignità». Una storia che la Chiesa del Sud Italia conosce bene, e che Saviano ha raccontato attraverso la vita di don Peppino Diana, il prete di Casal di Principe ucciso dalla camorra per la sua campagna di educazione e di denuncia contro i clan: «Appena morto, i giornali locali, amici dei boss, subito si sono messi a raccontare che don Peppino non era così buono, aveva le amanti, e così via»: la calunnia, la delegittimazione, la solitudine che tutto questo porta con sé sono il vero martirio dei testimoni di oggi, e spesso non c’è alcun bisogno di arrivare a uccidere il "testimone". Parlando appena qualche mese fa proprio nella basilica di San Bartolomeo, con alle spalle la grande icona dei Martiri del Ventesimo secolo, Saviano, che per il suo libro è stato minacciato dalla camorra e oggi vive sotto scorta, ha provato a spiegare cosa significhi il martirio nel nostro tempo, cosa comporti rendere testimonianza anche quando la propria vita è minacciata. Per lo scrittore, «il vero martirio, oggi, è la diffamazione, la distruzione della dignità». Una storia che la Chiesa del Sud Italia conosce bene, e che Saviano ha raccontato attraverso la vita di don Peppino Diana, il prete di Casal di Principe ucciso dalla camorra per la sua campagna di educazione e di denuncia contro i clan: «Appena morto, i giornali locali, amici dei boss, subito si sono messi a raccontare che don Peppino non era così buono, aveva le amanti, e così via»: la calunnia, la delegittimazione, la solitudine che tutto questo porta con sé sono il vero martirio dei testimoni di oggi, e spesso non c’è alcun bisogno di arrivare a uccidere il "testimone".
Allo stesso tempo, Saviano ha voluto però sottolineare la profonda "normalità" del martire: «Non sceglie la morte, sceglie la vita». Di fronte alla disumanità, di fronte alla stortura, «il martire risponde con una scelta di profonda coerenza, quella di difendere, con strenua resistenza, la propria dignità e quindi la propria umanità». In questa luce, il senso della parola martire si allarga e arriva ad andare al di là di chi è stato ucciso in odium fidei: lo scrittore parla anche di Anna Politkovskaja, la giornalista russa assassinata in circostanze mai chiarite: «Il suo terrore», racconta, «più che di essere uccisa, era quello di essere diffamata». Per questo, aggiunge, l’opera della Comunità è importante nel suo tentativo di preservare non solo la memoria ma la dignità dei testimoni, e per questo negli ultimi anni si è trovato a camminarle accanto.
Sono molti quelli che, dopo oltre quarant’anni di attività, oggi sono pronti a rendere "testimonianza" dell’opera della Comunità. Molti "piccoli", certo, ma anche molti "grandi", che, forse all’inizio per calcolo, a volte, più avanti, per convinzione, hanno deciso di venire a visitare quella che molti giornalisti, con un po’ di ironia, chiamano la piccola «Onu di Trastevere». Gli abitanti del quartiere romano si ricordano ancora le strade blindate, gli agenti a ogni angolo, i tombini scoperchiati, controllati e poi risigillati a uno a uno in preparazione dell’arrivo del presidente statunitense George W. Bush nel maggio del 2008 nella sede della Comunità. La visita poi, per le invocate ragioni di sicurezza, saltò, e l’incontro con i vertici di Sant’Egidio venne trasferito nella sede dell’ambasciata degli Stati Uniti.
Ma anche se manca ancora la visita di un presidente Usa in carica, nella piazzetta di Trastevere sono passati molti dei leader più influenti del pianeta, da Michael Gorbachev al leader moderato del Kosovo albanese Ibrahim Rugova, al segretario di Stato del presidente Bill Clinton, Madeleine Albright. Quest’ultima, di passaggio a Roma nel marzo del 1998, volle visitare la sede della Comunità e non risparmiò le lodi non solo per l’impegno di Sant’Egidio per la pace in vari scacchieri africani ma anche per la capacità di fornire "notizie fresche" su quanto accadeva in molte di quelle regioni devastate dalla guerra.
«Siete nati nel ’68, siete figli del ’68: questo dimostra che frutti buoni ce ne sono in tutte le stagioni!»: il 30 maggio del 1998, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro salutava così la Comunità di Sant’Egidio e il suo lavoro in occasione del suo trentesimo "compleanno". «Avete aiutato il dialogo in Mozambico, state aiutando il dialogo in Albania, per il Kosovo. Siete andati ad aiutare il dialogo in Guatemala. Aiutate il dialogo tra le religioni più diverse», elencava. Ma, precisava, «questo lavorare per la pace combatte una povertà che, se non è la prima in assoluto, certo, è una delle più terribili: la povertà della pace interiore, che determina solitudini e disperazioni grandissime». In questo modo, il capo dello Stato collegava l’origine della Comunità, il servizio nelle periferie ai poveri, ai barboni, agli emarginati delle periferie – iniziato quando la Comunità non aveva un nome e alcuni frequentavano Gioventù Studentesca – con il servizio di "diplomazia free-lance" che, decenni dopo, l’avrebbe resa famosa in tutto il mondo.
 Dalla mensa dei poveri ai trattati internazionali, per Scalfaro, il passo era stato meno lungo di quanto potesse sembrare: «È stato detto molto bene: i poveri, gli anziani, le persone che hanno bisogno di cose per ridurre la sofferenza, hanno bisogno del "modo", hanno bisogno di sentire che qualcuno si rivolge a loro. Non conta molto che sulla porta trovino i beni materiali di cui sono, magari, in condizioni di assoluta necessità: hanno bisogno di un sorriso, ma non gettato genericamente. Quel sorriso deve avere un "indirizzo". Quante volte noi, anche soltanto dallo sguardo di una persona che non conoscevamo prima, ma che era uno sguardo più intenso, abbiamo sentito che qualcuno ci è entrato in casa e ci ha aiutato a portare un peso». Dalla mensa dei poveri ai trattati internazionali, per Scalfaro, il passo era stato meno lungo di quanto potesse sembrare: «È stato detto molto bene: i poveri, gli anziani, le persone che hanno bisogno di cose per ridurre la sofferenza, hanno bisogno del "modo", hanno bisogno di sentire che qualcuno si rivolge a loro. Non conta molto che sulla porta trovino i beni materiali di cui sono, magari, in condizioni di assoluta necessità: hanno bisogno di un sorriso, ma non gettato genericamente. Quel sorriso deve avere un "indirizzo". Quante volte noi, anche soltanto dallo sguardo di una persona che non conoscevamo prima, ma che era uno sguardo più intenso, abbiamo sentito che qualcuno ci è entrato in casa e ci ha aiutato a portare un peso».
Come Scalfaro, molti sono stati i leader mondiali che hanno voluto ringraziare personalmente la Comunità per il proprio lavoro. Nel 2008, è stato il cancelliere tedesco Angela Merkel a invitare a Berlino i responsabili di Sant’Egidio, in segno di gratitudine per il loro contributo alla lotta all’Aids con il programma Dream, che si occupa di fornire, nella totale gratuità, farmaci retrovirali, cure mediche e assistenza a oltre 75 mila pazienti in cura in dieci Paesi africani.
 Nel 2005, l’annuale Incontro di preghiera per la Pace si teneva per la prima volta in terra francese, a Lione, proprio a cento anni dall’entrata in vigore della legge che aveva stabilito una rigorosa divisione tra Chiesa e Stato nel nome della laicité. A inaugurare i lavori dell’Assemblea c’era Nicolas Sarkozy, allora ancora ministro degli Interni, che lodò la scelta di tenere un incontro "religioso" in un Paese che celebrava una legge spesso interpretata come nemica tout court della religione. «Contrariamente all’immagine che essa ha ereditato dalla sua storia movimentata», spiegava il futuro presidente francese, «la laicità, "alla francese" non è nemica delle religioni. Essa è una costruzione politica, giuridica e umana che si sforza di conciliare il diritto di ogni individuo a praticare un culto e il divieto fatto a tutti di misconoscere questo bene così caro che è la libertà di coscienza». Nel 2005, l’annuale Incontro di preghiera per la Pace si teneva per la prima volta in terra francese, a Lione, proprio a cento anni dall’entrata in vigore della legge che aveva stabilito una rigorosa divisione tra Chiesa e Stato nel nome della laicité. A inaugurare i lavori dell’Assemblea c’era Nicolas Sarkozy, allora ancora ministro degli Interni, che lodò la scelta di tenere un incontro "religioso" in un Paese che celebrava una legge spesso interpretata come nemica tout court della religione. «Contrariamente all’immagine che essa ha ereditato dalla sua storia movimentata», spiegava il futuro presidente francese, «la laicità, "alla francese" non è nemica delle religioni. Essa è una costruzione politica, giuridica e umana che si sforza di conciliare il diritto di ogni individuo a praticare un culto e il divieto fatto a tutti di misconoscere questo bene così caro che è la libertà di coscienza».
Per Sarkozy, «oggi gli uomini e le donne vedono bene che la prosperità materiale non è sufficiente a soddisfare le aspirazioni profonde dell’uomo. Essa non è di nessun aiuto per distinguere il bene dal male. Essa non dà senso all’esistenza. Essa non risponde alle domande fondamentali dell’essere umano: perché c’è una vita e qual è il senso della morte? Anche la libertà e la democrazia non danno risposta... È per questo che, come vediamo tutti i giorni, le religioni hanno un ruolo determinante in questa riorganizzazione del mondo, delle società, delle idee. Esse, che sono per natura transnazionali, possono aiutare gli uomini a trovare un senso alla loro esistenza indipendentemente dalle frontiere o dalle identità nazionali, o in via complementare con esse». Il merito di una comunità come Sant’Egidio, quindi, era quello di aver scelto consapevolmente di valorizzare il modello "laico" francese e di essersi messa in dialogo con esso. Di aver messo la propria "anima" di fede dentro, e non contro, il mondo.
D’altra parte, «la capacità delle persone laiche di diffondere amore è molto più limitata di quella delle persone di fede religiosa. Ci sono miriadi di esperienze che ce lo dimostrano». A dirlo è un uomo politico e intellettuale che, da laico coerente ma sensibile ai temi della fede, si è spesso messo in dialogo con la Comunità di Sant’Egidio: Giuliano Amato. Per l’ex presidente del Consiglio, la reale differenza tra l’impegno di chi crede e di chi non crede sta nella minore capacità, da parte di questi ultimi, di "coinvolgere gli altri": «Questo è il problema e il vero limite della fede laica. Ciò che vedo nelle persone di fede religiosa è quello straordinario amore che hanno per gli altri, che li porta al sacrificio, ad accogliere altre persone in casa propria, a rinunciare perfino alla propria verità per amore».
Ma le due sfere non per questo devono rimanere estranee, incomunicabili: «Gli essere umani non sono palle di biliardo: una volta che si sono incontrati qualche cosa dell’altro rimane, comunque, in ciascuno. E questo è straordinariamente vero». Amato in quell’occasione – era il 2000, l’anno del Giubileo – parlava alla presentazione di un libro scritto da un altro intellettuale laico attento al valore della fede, Arrigo Levi, insieme al fondatore di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, e a un vescovo da sempre "vicino" alla Comunità, monsignor Vincenzo Paglia.
 Levi da molti anni ha avviato una lunga esperienza di «dialogo sulla fede, fede religiosa e fede laica» con la Comunità di Sant’Egidio, tanto più ricca quanto grande era la distanza dalla fede di un autoproclamato "libero pensatore". Eppure, parlando all’incontro di Assisi del 2006, Levi sottolineava l’importanza di essere «riuniti, anche se rimangono fra noi, sono parole di Giovanni Paolo II ad Assisi (nel 1986, ndr), "tante e importanti differenze", che non vogliamo né possiamo rinnegare». «O forse», aggiungeva, «sono proprio le differenze che ci spingono a incontrarci: ci spinge l’ansia di conoscerci meglio, di capirci attraverso il confronto delle nostre idee». Confronto tra chi crede e chi non crede, o tra chi crede in fedi diverse, perché «il dialogo non conduce al dissolvimento della propria fede; anzi, l’astuzia dello Spirito fa sì che la conoscenza della fede altrui rafforzi la propria». Levi da molti anni ha avviato una lunga esperienza di «dialogo sulla fede, fede religiosa e fede laica» con la Comunità di Sant’Egidio, tanto più ricca quanto grande era la distanza dalla fede di un autoproclamato "libero pensatore". Eppure, parlando all’incontro di Assisi del 2006, Levi sottolineava l’importanza di essere «riuniti, anche se rimangono fra noi, sono parole di Giovanni Paolo II ad Assisi (nel 1986, ndr), "tante e importanti differenze", che non vogliamo né possiamo rinnegare». «O forse», aggiungeva, «sono proprio le differenze che ci spingono a incontrarci: ci spinge l’ansia di conoscerci meglio, di capirci attraverso il confronto delle nostre idee». Confronto tra chi crede e chi non crede, o tra chi crede in fedi diverse, perché «il dialogo non conduce al dissolvimento della propria fede; anzi, l’astuzia dello Spirito fa sì che la conoscenza della fede altrui rafforzi la propria».
La ricerca di una saldezza nella fede che non scuotesse la fedeltà al mondo, alla terra, che ha segnato la Comunità di Sant’Egidio, non è stata capace di attirare solo i "lontani", non credenti, laici in ricerca, o potenti coscienti della necessità di un fondamento "altro" per il proprio potere. Ha funzionato anche dove spesso è più difficile, tra i "vicini": sono moltissimi gli uomini di Chiesa che hanno lasciato una testimonianza della propria prossimità alla storia e al cammino di Sant’Egidio, preti, vescovi dei cinque Continenti, religiosi, patriarchi delle Chiese orientali. Tra tanti, particolarmente emblematico è il racconto dell’arcivescovo emerito di Milano, cardinale Carlo Maria Martini. Il suo primo incontro con la Comunità sembra quasi la sintesi dei molti nodi che stanno dietro alla nascita di Sant’Egidio: «All’inizio degli anni Settanta», raccontava il cardinale nel 1995, «camminavo per le strade di Trastevere e riflettevo tra me e me su una certa lacerazione che allora esisteva nell’immediato dopo-Concilio tra coloro che puntavano sull’impegno per i poveri, per la trasformazione della società, e coloro che puntavano invece tutto sulla spiritualità, sulla preghiera, e mi dicevo: "Deve pur esistere una conciliazione pratica, un modo di unire praticamente nella vita il senso del primato di Dio, del primato della Parola, del primato della preghiera e un’urgenza pratica, efficiente, di amore per i poveri, di vicinanza ai più poveri, di vicinanza alla gente, alle persone più abbandonate". Ed ecco che mentre riflettevo tra me e me, passeggiando per le stradine di Trastevere, vidi un giovane che portava tra le mani un libro della Bibbia e mi dissi: "Qui ci deve essere qualcosa". Allora non riuscii a identificarlo e vidi che spariva dietro una porticina. Avevo una grande curiosità di andargli dietro, ma non osai farlo».
 Da quella "porticina" Martini sarebbe passato di lì a qualche mese, dando inizio a un lungo dialogo. Ma già pochi anni dopo quel primo incontro, il cardinale, invitato a predicare nella chiesa di Sant’Egidio, rifletteva sul futuro di una Comunità nata all’insegna della doppia testimonianza della "carità" e della "pace": c’è una responsabilità «profetica», diceva, nella pratica della preghiera e del dialogo che caratterizzano Sant’Egidio. Ma Martini indicava anche la peculiare "testimonianza" richiesta dal fatto che la Comunità fosse così fortemente segnata dal proprio luogo di origine, dall’essere figlia della città di Roma. «Il vostro inizio è Roma e un grande dono che vi è stato dato è quello di mostrare che Roma può essere una città esemplare. La dimensione cittadina del vostro servizio ai poveri è qualcosa di inedito». Una dimensione che andava testimoniata «salvando la prossimità» anche quando la Comunità si trovava a «operare nei grandi contesti nazionali e internazionali: il samaritano non è solo colui che incontra il ferito, ma anche colui che si preoccupa della situazione di lacerazione di una nazione». Perché solo chi sa essere vicino al ferito non scade «nella burocrazia che rischia di spersonalizzare e vanificare, come accade per molti grandi sforzi internazionali che richiedono a volte enormi capitali per minimi risultati». Da quella "porticina" Martini sarebbe passato di lì a qualche mese, dando inizio a un lungo dialogo. Ma già pochi anni dopo quel primo incontro, il cardinale, invitato a predicare nella chiesa di Sant’Egidio, rifletteva sul futuro di una Comunità nata all’insegna della doppia testimonianza della "carità" e della "pace": c’è una responsabilità «profetica», diceva, nella pratica della preghiera e del dialogo che caratterizzano Sant’Egidio. Ma Martini indicava anche la peculiare "testimonianza" richiesta dal fatto che la Comunità fosse così fortemente segnata dal proprio luogo di origine, dall’essere figlia della città di Roma. «Il vostro inizio è Roma e un grande dono che vi è stato dato è quello di mostrare che Roma può essere una città esemplare. La dimensione cittadina del vostro servizio ai poveri è qualcosa di inedito». Una dimensione che andava testimoniata «salvando la prossimità» anche quando la Comunità si trovava a «operare nei grandi contesti nazionali e internazionali: il samaritano non è solo colui che incontra il ferito, ma anche colui che si preoccupa della situazione di lacerazione di una nazione». Perché solo chi sa essere vicino al ferito non scade «nella burocrazia che rischia di spersonalizzare e vanificare, come accade per molti grandi sforzi internazionali che richiedono a volte enormi capitali per minimi risultati».
Alessandro Speciale
Il buon profumo di "casa Sant’Egidio"
 «Il mondo è spesso grigio, triste: il mondo cristiano, in particolare, non è davvero entusiasmante in questo momento, ma la Comunità fa parte di quelle realtà che permettono di sperare, di avere ancora fiducia, di pensare che il cristianesimo non è soltanto un sentimentalismo o un verbalismo, ma una realtà»: lo diceva, nel 1998, Olivier Clément, lo scrittore, poeta e teologo ortodosso che proprio quell’anno aveva preparato le riflessioni per la Via Crucis al Colosseo. «Il mondo è spesso grigio, triste: il mondo cristiano, in particolare, non è davvero entusiasmante in questo momento, ma la Comunità fa parte di quelle realtà che permettono di sperare, di avere ancora fiducia, di pensare che il cristianesimo non è soltanto un sentimentalismo o un verbalismo, ma una realtà»: lo diceva, nel 1998, Olivier Clément, lo scrittore, poeta e teologo ortodosso che proprio quell’anno aveva preparato le riflessioni per la Via Crucis al Colosseo.
A Sant’Egidio, nata dopo il Concilio, nata sull’onda del Concilio, sono passati molti dei personaggi che hanno segnato la storia del rinnovamento della Chiesa a partire dall’esperienza del Vaticano II. «Un santuario del Vangelo e un testimone della fedeltà al Concilio Vaticano II»: così, ad esempio, definiva la Comunità di Sant’Egidio il cardinale francese Léon-Ètienne Duval, arcivescovo di Algeri dal 1954 al 1988 e sostenitore, negli anni della decolonizzazione, della causa dell’indipendenza algerina, tanto da guadagnarsi in patria il soprannome di «Mohammed Duval».
Nei ricordi di chi l’ha conosciuta sin dagli inizi, risalta in maniera evidente il legame diretto tra la Comunità e il Concilio. Vi fa più volte riferimento anche il cardinale Ugo Poletti, cardinale vicario di Roma dal 1973 al 1991, che – come lui stesso ha raccontato in occasione dei venti anni di Sant’Egidio – ha visto la Comunità «crescere qui a Roma, prima quasi timidamente nelle scuole, nelle borgate, poi man mano nella grande periferia della città, mescolandosi alla vita parrocchiale, nelle nostre comunità parrocchiali. Abbiamo camminato insieme, siamo cresciuti insieme, conoscendoci sempre più di giorno in giorno, amandoci». Egli metteva in evidenza «il senso meraviglioso dell’ospitalità, della fratellanza universale», della Comunità, «cercando sempre nuove frontiere, sempre più avanzate, sempre più approfondite, nella storia dolente dell’umanità: sia la frontiera dell’immigrazione degli stranieri, sia la frontiera degli zingari e poi le frontiere del dialogo; questa espressione così bella; il dialogo con i fratelli delle altre confessioni cristiane e delle altre religioni».
Yves Congar, il grande teologo domenicano del Concilio, nel 1983 raccontava addirittura di sentirsi «molto piccolo» in mezzo alla Comunità: «Io faccio della teologia», spiegava, «e c’è bisogno anche che questa venga fatta: c’è bisogno di tutto per costruire il mondo, coma dice il proverbio, anche dei teologi. Ma io non sono concretamente a contatto con i poveri, con i drogati, con gli ex carcerati, con i vecchi, gli anziani, mentre voi ci siete!».
La preghiera e i poveri: sembra essere questo che colpisce di più i testimoni che si trovano a passare dalla Comunità. Ancora Clément, nel trentesimo anniversario di Sant’Egidio, ricorda che «le cose acquisite della Comunità che mi hanno sempre colpito, qui a Roma, sono la preghiera e l’aiuto concreto ai più poveri. Sono assolutamente inseparabili: entrambi rappresentano una grande lezione per gli uomini di oggi, tentati di vivere un cristianesimo un po’ schizofrenico, con molte cose mistiche, ma che non cambiano la vita». «Una piccola storia», concludeva, «dice che quando si abita in un appartamento non si sa più qual è il proprio profumo, ma l’ospite che viene da fuori sente subito il profumo nell’appartamento. A Sant’Egidio il profumo è molto buono».
a.sp.
Lo spirito di Assisi soffia ancora
La prima volta che la Comunità di Sant’Egidio comparve veramente sulla ribalta internazionale fu in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la pace, voluta da papa Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986. Il 27 ottobre di quell’anno, 50 rappresentanti delle Chiese cristiane e 60 rappresentanti delle altre religioni mondiali, oltre a numerosi esponenti cattolici, si misero l’uno accanto all’altro nella città di san Francesco per invocare la pace e per dire "no" all’orrore della guerra.
 In quell’incontro era confluita anche la fitta rete di contatti e relazioni che da anni la Comunità di Sant’Egidio aveva cominciato a tessere dentro e fuori l’Ecumene cristiana. Sfogliando il "libro degli ospiti" della sede di Trastevere o degli Incontri annuali che, a partire dal 1987, la Comunità organizza ogni anno per promuovere e approfondire lo "spirito di Assisi", si incontrano i nomi dei leader spirituali di tutto il pianeta. In quell’incontro era confluita anche la fitta rete di contatti e relazioni che da anni la Comunità di Sant’Egidio aveva cominciato a tessere dentro e fuori l’Ecumene cristiana. Sfogliando il "libro degli ospiti" della sede di Trastevere o degli Incontri annuali che, a partire dal 1987, la Comunità organizza ogni anno per promuovere e approfondire lo "spirito di Assisi", si incontrano i nomi dei leader spirituali di tutto il pianeta.
Da sempre, Sant’Egidio ha coltivato un rapporto particolarmente forte con l’Ortodossia: negli anni, l’attuale patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, il patriarca di Romania Daniel, il catholicos degli armeni Aram I, il patriarca di Cipro Chrysostomos II hanno partecipato agli incontri organizzati dalla Comunità. Chiudendo l’ultimo incontro per la Pace, a Cipro nel 2008, Chrysostomos ricordava che «l’impegno per la pace e di conseguenza per la giustizia, la fraternità e la libertà, non conosce limiti e frontiere, né restrizioni religiose o confessionali. È questa la causa che ci ha unito in questi tre giorni: cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddhisti, uomini di tutte le fedi. Forse non tutti crediamo nello stesso Dio, ma come persone, avendo la stessa natura, siamo ugualmente sensibili verso i grandi problemi dell’umanità».
Incontri, certo, non privi di problemi, come testimonia il franco scambio di battute tra il rabbino capo di Israele Yona Metzger e il fondatore dell’università degli Emirati Arabi Ezzedin Ibrahim, a tavola insieme a papa Benedetto XVI, durante l’Incontro di Napoli del 2007. Ma il valore degli incontri va al di là delle polemiche e delle questioni politiche del momento.
Lo testimonia, ad esempio, il teologo musulmano Mohammed Esslimani, per il quale «Sant’Egidio ha modificato il dialogo, ha percorso degli spazi e ha trattato delle questioni che sono particolarmente spinose, ha affrontato pure degli argomenti di cui gli altri non trattano». Un dialogo onesto, serio, ma allo stesso tempo aperto alla possibilità di una comprensione profonda, spirituale dell’altro, e non solamente intellettuale, è per il rabbino David Rosen, la ragione stessa di un simile dialogo: «Stabilire una civiltà della coesistenza è essenziale per impedire che la società si autodistrugga, così come per impedire a chiunque di fare il male a qualcun altro. Tuttavia, l’imperativo religioso delle nostre rispettive tradizioni religiose ci richiede di andare oltre, di creare una civiltà del mutuo rispetto, che scaturisce dal riconoscere che ogni persona è creata a immagine di Dio, cioè è di inestimabile valore, e che gli individui e le collettività sono doni divini che se rispettati possono arricchire e fare sviluppare l’intera società».
I frutti di quest’impegno si colgono, ad esempio, nella moratoria sulla pena di morte approvata dall’Onu nel 2007: «Dio» scriveva allora l’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, «è fiero di voi, lo fate sorridere un po’».
a.sp.
Napolitano: intelligenza e passione cristiana
 «Un’oasi, chiamiamola così, nell’Italia che ci circonda così agitata e confusa in questo momento. Un’oasi di raccoglimento, un’oasi di rinnovato impegno attorno a valori alti che dovrebbero guidare, in effetti, chiunque voglia dedicarsi in Italia al bene comune»: questa, per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è la Comunità di Sant’Egidio nel non sempre roseo panorama del nostro Paese. Il capo dello Stato pronunciava queste parole nella basilica di San Giovanni in Laterano il primo febbraio del 2008, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione della Comunità. «Un’oasi, chiamiamola così, nell’Italia che ci circonda così agitata e confusa in questo momento. Un’oasi di raccoglimento, un’oasi di rinnovato impegno attorno a valori alti che dovrebbero guidare, in effetti, chiunque voglia dedicarsi in Italia al bene comune»: questa, per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è la Comunità di Sant’Egidio nel non sempre roseo panorama del nostro Paese. Il capo dello Stato pronunciava queste parole nella basilica di San Giovanni in Laterano il primo febbraio del 2008, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione della Comunità.
Il presidente Napolitano ad Assisi nella stessa occasione (foto D. Colarieti/ Catholic Press Photo/Periodici San Paolo).
«Io», proseguiva il capo dello Stato nel suo discorso, «desidero solo rivolgervi delle parole di riconoscimento e di augurio, a voi tutti cari amici di Sant’Egidio». Parole di riconoscimento e di augurio, «che vi rivolgo a nome di tutti gli italiani che hanno avuto modo di conoscervi e di apprezzarvi, e che sono dovuti. Sono dovuti per la dedizione che avete dimostrato alla causa della pace e dei diritti umani, per quello che rappresentate: una realtà originale, una comunità ecclesiale e sociale che si impegna religiosamente, culturalmente e civilmente».
Il presidente della Repubblica rintraccia la radice di questo impegno nella «profonda, sincera, ispirazione cristiana» della Comunità; anzi, aggiungeva, «se mi è permesso dirlo, passione cristiana». «Vi ha mosso anche», proseguiva, «una grande intelligenza delle cose del mondo, una capacità di guardare lontano, una capacità di portare il vostro messaggio e il vostro contributo anche in altri continenti e in modo particolare in Africa. E vorrei aggiungere che a questa grande intelligenza delle cose del mondo si è accompagnata una singolare vostra capacità di iniziativa diplomatica e costruttiva, perché voi avete dato anche un apporto importante anche alla costruzione di nuovi Stati indipendenti e di società più libere e più coese». Tutti, concludeva il capo dello Stato, «ci ispiriamo a un principio di sussidiarietà», perché «c’è bisogno delle istituzioni pubbliche e c’è bisogno di istituzioni come la vostra, che rappresentano energie vive e grandi risorse di cui l’Italia dispone e che non sempre vengono valorizzate come sarebbe giusto, ma sulle quali sappiamo di poter contare per guardare con maggior speranza e fiducia all’avvenire».
Già nel 2006 Napolitano era intervenuto alla solenne cerimonia di chiusura dell’Incontro mondiale per la pace ad Assisi. Ma l’amicizia è passata attraverso numerosi incontri istituzionali, da quelli legati all’impegno per l’Africa della Comunità a quelli portati dall’attività del progetto Dream contro l’Aids, fino all’occasione offerta dalla storica votazione da parte dell’Assemblea generale Onu della moratoria sulla pena di morte.
a.sp.
|
|
|

